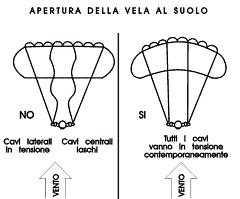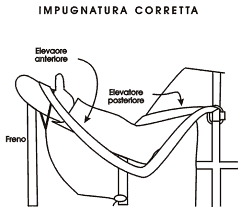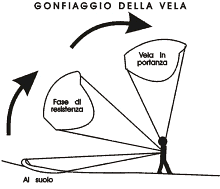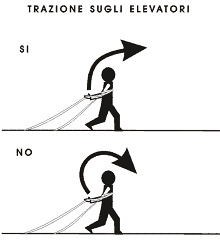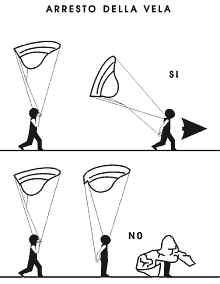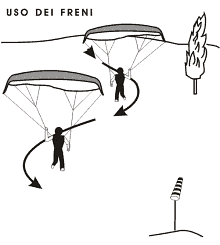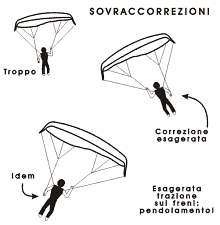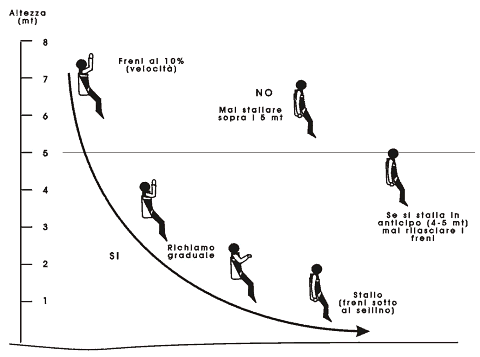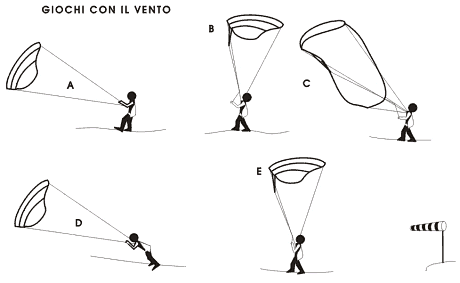|
AL CAMPO SCUOLA
APERTURA DELLA VELA AL SUOLO
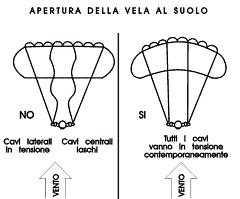
Figura 6-6. I primi cavi ad entrare in trazione devono essere quelli centrali: disporre la vela a "ferro di cavallo".
|
Disporre correttamente la vela al suolo è semplicemente fondamentale per poter effettuare un corretto gonfiaggio (ed il conseguente decollo), e questo per una ragione fisica facilmente comprensibile. Sappiamo, infatti, che l'aria deve gonfiare la vela entrando attraverso le bocche e distribuirsi, poi, attraverso i fori delle centine. Questo avviene soltanto se la prima parte di vela che si gonfia è quella centrale: le parti laterali vengono sollevate passivamente (anche sgonfie) e la completa apertura è assicurata dai fori di cui sopra.
Se, al contrario, si gonfiano per prime le parti laterali, esse si sollevano e convergono verso il centro, facendo collassare la bocche della parte centrale: il risultato è che la vela si accartoccia senza mostrare alcuna tendenza ad assumere la configurazione di volo.
Dal momento che il gonfiaggio viene effettuato dal pilota trazionando gli elevatori anteriori è necessario che questi agiscano prima sulla parte centrale che su quelle laterali. In altre parole la parte centrale deve essere più distante dal pilota rispetto alle parti laterali: questo si ottiene disponendo la vela a semicerchio (o "a ferro di cavallo"), con le bocche centrali bene aperte (Fig. 6-6).
ISPEZIONE DELLA VELA E POSIZIONAMENTO DEI FRENI
Proprio sul campetto, dove le possibilità di errore dovrebbero poter essere ampiamente "perdonate", è indispensabile prendere l'abitudine di verificare con attenzione la vela stessa e, soprattutto, la disposizione dei cavetti e dei freni.
I cavetti devono essere tutti "a vista" (nessun cavetto deve passare tra vela e terreno) e privi di nodi o grovigli: particolare attenzione andrà rivolta ai cavetti laterali che, anch'essi, devono giacere sopra agli stabilizzatori, e non essere, invece, nascosti da questi.
I cordini dei freni dovranno essere disposti sul terreno, più esternamente rispetto a tutti gli altri , in modo da poterne verificare completamente il decorso.
CONTROLLO DEI "GIRI DI IMBRAGO"
Quando, come accade sovente nei campi scuola, la selletta viene mantenuta costantemente attaccata alla vela, può accadere che essa compia uno o più giri su sè stessa: prima di "indossarla" è dunque indispensabile verificare che sia correttamente allineata.
Per fare ciò si solleva la selletta tenendola per i cosciali; l'altra mano scorre, sempre a contatto con i materiali, partendo da sotto alla selletta, passando sui fianchi delle fasce, risalendo fino ai moschettoni: a questo punto la mano deve trovarsi sulla faccia anteriore degli elevatori anteriori ; se i cavi che partono dagli elevatori anteriori raggiungono il bordo di entrata della vela senza "attorcigliarsi" con i cavi posteriori, possiamo essere certi che la selletta e correttamente posizionata. Altrimenti sarà necessario farla girare su sè stessa e ripetere la manovra di controllo.
ALLACCIATURA
L'allacciatura alla selletta deve essere effettuata avvicinandosi di qualche metro alla vela stessa: altrimenti le ripetute trazioni sui cordini rovineranno completamente l'attento lavoro di disposizione della vela al suolo prima effettuato. Soltanto al momento del gonfiaggio si deciderà, in base alla forza del vento, quale distanza deve effettivamente essere presa rispetto alla vela. A questo punto si infilano le spalline e si fermano i tre punti di aggancio: i due cosciali ed il pettorale , verificando la giusta posizione e la tenuta delle fibbie di sicurezza.
È opportuno fare subito una piccola distinzione tra questi tre punti: i due cosciali sono punti fondamentali , nel senso che sono loro a mantenerci "attaccati" alla vela, ed un loro errato aggancio (con cedimento od apertura in volo) è indubbiamente drammatico.
Il pettorale, invece, ha una funzione meno "vitale" anche se importante: esso impedisce un eccessivo allontanamento degli elevatori (destri e sinistri) che vengono trazionati, non soltanto verso l'alto ma anche verso l'esterno, dai fasci funicolari.
Il mancato aggancio del pettorale è ancora compatibile con un volo "controllabile", ma la sensazione di "cadere in avanti" è, specie agli inizi, molto spiacevole ed angosciante, anche se le spalline, di fatto, impediscono che questo avvenga.
IMPUGNAMENTO DEGLI ELEVATORI ANTERIORI E DEI FRENI
Questa operazione presenta, inizialmente, una difficoltà notevole, ma diviene rapidamente automatica quando si adotta un "sistema" standard.
L'importante è che le nostre mani impugnino i freni e gli elevatori anteriori mentre gli elevatori posteriori giacciono sugli avambracci (Fig. 6-7).
Raggiunta tale posizione si verifica, sollevando le braccia ed allontanandosi leggermente dalla vela (occhio a non "scompigliarla"), che i cavi anteriori siano completamente liberi lungo tutto il bordo di attacco.
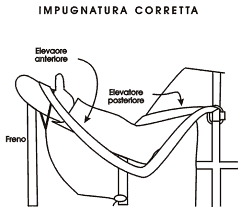
|
|
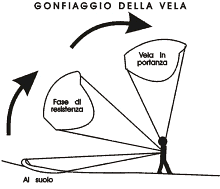
|
Figura 6-7. Impugnatura corretta: l'elevatore posteriore passa sopra all'avambraccio |
|
Figura 6-8. I due momenti del gonfiaggio: bisogna essere pronti a "vincere" la fase di resistenza. |
GONFIAGGIO, ASSETTO DI DECOLLO ED ARRESTO
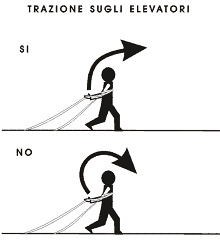
Figura 6-9. La trazione sugli elevatori deve essere rivolta in avanti ed in alto.
|
Iniziando ad avanzare controvento, con una corsa progressiva, si compie un ampio movimento con le braccia, trazionando gli elevatori anteriori in avanti e verso l'alto: la vela, gonfiandosi, oppone una certa resistenza fintantochè è dietro di noi; poi, dopo una rapida salita, raggiunge la nostra verticale e, se glielo consentiamo (ad esempio rallentando la corsa, oppure tirando verso il basso gli elevatori anteriori che teniamo in mano), ci supera per afflosciarsi subito dopo.
Il secondo obbiettivo, una volta in grado di gonfiare la vela, è quello di raggiungere e mantenere l'assetto di decollo , cioè correre per alcune decine di metri (su un terreno pianeggiante) mantenendo la vela sulla verticale: perchè questo sia possibile è necessario che la nostra velocità sia uguale alla velocita di volo della vela stessa. Mentre è intuitivo che possiamo accelerare o frenare la nostra stessa corsa, è meno immediatamente evidente che, tramite i freni, possiamo accelerare o frenare anche la velocità della vela .
Una volta terminato il gonfiaggio (anzi, qualche attimo prima che la vela sia sulla verticale), abbandoniamo gli elevatori anteriori ed abbassiamo leggermente i freni, proseguendo la corsa. Se la vela tende a sopravanzare, acceleriamo la corsa e, contemporaneamente, trazioniamo maggiormente i freni. Se la vela rimane indietro, rallentiamo per un attimo, rilasciando completamente i freni; in alcuni casi, se la vela tende a "cadere all'indietro" può essere necessario riprendere gli elevatori anteriori e ripetere la fase di gonfiaggio esercitando, come prima, una trazione verso l'alto ed in avanti (mai verso il basso) (Fig. 6-9).
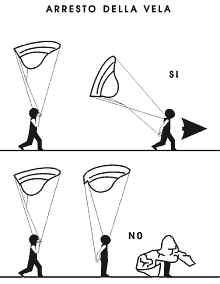
Figura 6-10. Per arrestare la vela è necessario frenarla e, contemporaneamente, avanzare con il corpo.
|
Esaurito lo spazio disponibile è ora necessario fermare la vela che, idealmente, deve adagiarsi al suolo dietro di noi senza eccessivi ingarbugliamenti dei cavi: questo viene ottenuto frenando completamente la vela (freni ad altezza natiche) e continuando ad avanzare ; se ci si ferma troppo presto, la vela scende sulla nostra testa, legandoci con i suoi cordini (Fig. 6-10).
NON APPENDERSI AGLI ELEVATORI !
Un errore molto frequente (quasi costante!) consiste nel trazionare verso il basso gli elevatori anteriori (appendersi agli elevatori): il risultato immediato è che la vela accelera, ci supera, e si affloscia davanti a noi o sopra di noi. Deve infatti essere chiaro che, quando la vela è dietro di noi (mentre si stà gonfiando) una trazione sugli elevatori corrisponde ad una trazione in avanti della vela, mentre quando questa è sopra di noi, la stessa trazione diviene una trazione verso il basso di tutto il bordo di attacco, il che, come sappiamo dalla aerodinamica, si traduce in una riduzione dell'angolo di incidenza ed in una accelerazione.
Per evitare tale errore è utile suggerire all'allievo di aprire le mani (badando a non lasciare andare i freni), non appena la vela ha iniziato a sollevarsi. Con gli elevatori anteriori che appoggiano sui palmi delle mani è ancora possibile spingerli in avanti, ma è invece impossibile tirarli verso il basso.
Un secondo errore, ma sarebbe meglio definirlo un'insieme di errori, consiste nel correre in modo disordinato, agitando le braccia (che reggono i freni) per aiutarsi a mantenere l'equilibrio. Sui campetti (e purtroppo non solo lì) se ne vedono di tutti i colori: corse con le braccia allargate ad aereo (quasi dovessero essere loro le nostre ali) che oscillano paurosamente a destra ed a manca. Salti e ricadute che aggiungono e tolgono peso alla vela, impedendole di stabilizzarsi. Improvvise frenate ed accellerate.
La vela è molto leggera e, per volare, richiede una corsa ed un carico più uniformi possibile. Ogni "strattonata", modificando la forma, ne interrompe l'involo, e l'allievo corre, corre, senza che essa mostri alcun desiderio di stabilizzarsi su di lui.
La corsa in assetto di decollo deve invece essere lineare, le braccia ripiegate mantengono i freni all'altezza delle orecchio, i gomiti a contatto con il corpo impediscono movimenti disordinati, la velocità non subisce brusche variazioni.
CONTROLLO DIREZIONALE
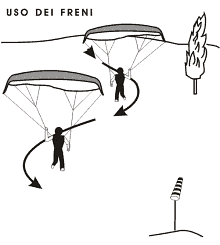
Figura 6-11. Anche correndo sul prato è possibile pilotare la vela agendo sui freni: è molto utile saggiarne la risposta fin dai primi esercizi.
|
Già durante le corse in piano è utile "saggiare" l'effetto dei singoli freni sull'ala, trazionando ora l'uno ora l'altro e correggendo anche la traiettoria di corsa per mantenere l'ala sempre sulla verticale (Fig. 6-11).
LO STACCO E IL VOLO
PRIMI STACCHI (5-10 mt)
Se le operazioni di gonfiaggio e corsa in assetto di decollo sono eseguite correttamente, è sufficiente compiere le stesse manovre su di un terreno con una pendenza lievemente superiore per sentirsi sollevare dolcemente e decollare. Dal momento però che, prevedibilmente, ci si staccherà dal suolo, diviene indispensabile introdurre un nuovo, fondamentale, momento che, d'ora in poi, non tralasceremo mai: il controllo visivo della vela.
CONTROLLO VISIVO DELLA VELA
Prima di "prendere il volo", al termine della fase di gonfiaggio, è indispensabile verificare visivamente che la vela sia nel giusto assetto: tutti i cassoni gonfi, i cavetti ben distesi, i freni liberi da "giri" che impedirebbero le manovre in volo. A differenza di quanto accade, ad esempio, con il deltaplano, in parapendio è sempre possibile "abortire" un decollo (vedi le osservazioni sulla scelta del terreno di decollo), interrompendolo con un rallentamento ed una "affondata" di freni, nel caso il gonfiaggio non sia perfettamente riuscito. Il controllo visivo serve anche per rilevare eventuali asimmetrie di assetto (vela che si alza più da una parte che dall'altra) e correggere, se necessario, azionando il freno della parte più alta.
LO STACCO VERO E PROPRIO
Specie ai primi tentativi il movimento della corsa, se disordinato, può impedire alla vela di sviluppare portanza e la corsa stessa prosegue per decine di metri senza che ci si senta sollevati. In questo caso i nostri sforzi saranno volti a mantenere un assetto di corsa ordinato ed uniforme.
In altri casi la corsa, pur ordinata, accelera continuamente, fino al raggiungimento della nostra capacità di velocità massima, senza alcun decollo: in questo caso è necessario frenare maggiormente la vela posizionando i freni all'altezza delle spalle, anzichè delle orecchie. Come vedremo tra breve, infatti, i freni, oltre che per le virate, devono essere utilizzati (insieme) per modificare le velocità di volo e l'inclinazione della traiettoria. Una maggiore azione sui freni si traduce in una maggiore efficienza (oltre che in un rallentamento) ed è probabile che, sullo stesso pendio di prima, ora si riesca a "staccare" dolcemente. Riassumento, quindi, se stiamo correndo con la vela gonfia al massimo della nostra velocità senza staccarci dal suolo (e non stiamo tentando di decollare con il vento posteriore) probabilmente stiamo tenendo le mani troppo alte.
"CARRELLO" ESTRATTO E FRENI ALLE ORECCHIE
Per la frequenza con cui si presentano, vale la pena di analizzare due errori , tipici del campetto, dai quali ci dobbiamo liberare prima di passare ai voli veri e propri.
Il primo è quello di "buttarsi" nella selletta sollevando le gambe in avanti alle prime avvisaglie di portanza: il risultato, di solito, è un brusco ritorno al terreno e benedetta sia l'asse di compensato, sottile diaframma tra la parte più morbida del corpo ed il ruvido terreno. Bisogna infatti ricordare che, affidando di colpo tutto il nostro peso alla vela, questa tende ad accelerare bruscamente ed a perdere un metro o due (in genere ben più della distanza che separa i due elementi sopra citati).
Pertanto, quando percepiamo le prime avvisaglie di "stacco", semplicemente ignoriamole, proseguendo la corsa come se nulla fosse: molto meglio fare un paio di falcate a vuoto che pestare pesantemente l'osso sacro .
Il secondo errore, ancora più grave, consiste nell'abbassare bruscamente i freni nel tentativo di recuperare l'equilibrio precario: ora e per sempre ricordiamo che, tranne che nel momento dello stallo finale, i freni non devono mai essere abbassai al di sotto dell'ombelico (e mai e poi mai al di sotto del sellino).
Ciò che accade in seguito a questo errore è molto semplice: la vela rallenta bruscamente sollevandoci e facendoci penzolare in avanti (come in altalena), quindi si chiude, in risposta al nostro (involontario) comando, deponendoci al suolo con una violenza che dipende soltanto dall'altezza raggiunta in quel momento. Forse proprio per evitare tale (madornale) errore molti istruttori preferiscono fare effettuare i primi stacchi con i freni completamente rilasciati (braccia distese in alto).
MANTENIMENTO DI UNA TRAIETTORIA RETTILINEA
Il passaggio dal suolo all'aria è, ai primi tentativi, il passaggio dal movimento caotico ad una perfetta e quasi magica quiete: una volta in volo, lo sguardo è in avanti (e non puntato sulla verticale sotto di noi), i piedi sono vicini e le gambe in lieve flessione. Se una piccola bolla ci solleva (e noi non lo desideriamo), alziamo i freni, in modo da aumentare non soltanto la velocità orizzontale, ma anche quella verticale. Al contrario, trazionando i freni, l'effetto "sollevante" della bolla sarà maggiore.
In nessun caso, comunque, i freni verranno abbassati oltre la linea delle spalle.
PRIME CORREZIONI DI ROTTA
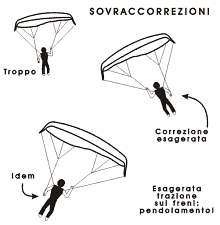
Figura 6-12. Le correzioni eccessive (sovraccorrezioni) innescano un pendolamento laterale.
|
Un concetto fondamentale del volo in generale, che si applica puntualmente anche al parapendio, è che le correzioni di rotta e le virate sono il risultato di due distinti fattori: entità del comando e tempo durante il quale il comando viene impartito. In altre parole bisogna lasciare il tempo all'ala di "registrare" il nostro comando e di reagire ad esso.
L'azione sul freno deve quindi essere moderata, graduale e protratta , cioè l'esatto contrario di potente, brusca e brevissima .
Al comando dell'istruttore, quindi, il freno interno alla virata verrà dolcemente abbassato di 5-15 cm e mantenuto in tale posizione fino a che l'ala non risponde, virando. Per ripristinare il volo rettilineo sarà sufficiente riportare il freno alla stessa altezza di quello controlaterale e, ancora una volta, attendere qualche secondo .
Essendoci passati, proviamo a ricordare i pensieri che erano alla base degli errori di controllo laterale nei nostri primi stacchi:
"Devo virare a destra quindi ...", brusco abbassamento del freno destro (20-30 cm!) e suo immediato risollevamento "... non si sa mai". Nessun effetto. "Ora riprovo ...", altra strattonata a destra e, immediatamente, "non succede nulla ... devo abbassare di più", ulteriore abbassamento del freno: il risultato è una notevole inclinazione di lato che ci sorprende per la sua entità, "è troppo, devo correggere ... ", brusca strattonata del freno controlaterale, ed inizio di un pendolamento laterale che solo il morbido prato smorza quando si giunge al suolo.
Chissà perchè il tempo sembra dilatarsi durante i primi stacchi ed i secondi necessari per ottenere la virata sembrano minuti. All'inizio, quindi, le correzioni di rotta saranno minime, proprio per prendere confidenza con i "tempi" dell'ala.
ATTERRAGGIO
Dopo il breve stacco<+> il terreno, inesorabile, ci richiama a sè: ad un'altezza di circa 2-3 metri iniziamo ad abbassare entrambe i freni e concludiamo la manovra di stallo portandoli sotto alla selletta quando ormai i nostri piedi sono a mezzo metro dal suolo. Le gambe, il nostro carrello, saranno pronte ad ammortizzare il lieve impatto, facendo qualche passo in avanti per smaltire la eventuale velocità orizzontale residua e consentire alla vela di ricadere dietro di noi anzichè sul nostro capo (proseguendo la pratica scopriremo presto che arrestarsi magicamente a 5 cm da suolo non è un obbiettivo irraggiungibile, con il parapendio).
Gli errori possibili sono sostanzialmente tre.
1) Stallare troppo presto, cioè troppo in alto . Se stalliamo a 3-4 metri subiremo semplicemente un atterraggio "brusco", a patto che non ci venga in mente di rilasciare completamente i freni, nel tentativo di correggere l'eccessivo anticipo della manovra: sotto ai 5 metri quando la decisione di stallare è presa, deve essere mantenuta; del resto mai, per nessuna ragione, abbasseremo completamente i freni ad un'altezza superiore ai 5 metri, pena la chiusura della vela ed un arrivo a velocità (troppo) sostenuta.
2) Stallare troppo tardi, cioè quando già i piedi stanno già toccando il suolo : proprio per la latenza di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, sarà come non stallare affatto; grazie al cielo il parapendio è molto più "buono" del deltaplano con questo tipo di errore ed una ruzzolata sul prato, se morbido e privo di rocce, sarà tutto.
3) Stallare ad un altezza giusta, ma in modo asimmetrico (tirando più un freno dell'altro): in presenza di vento tale asimmetria si traduce in una virata che può portarci ad atterrare con il vento di traverso, se non decisamente dietro; è dunque importante mantenere una perfetta orizzontalità.
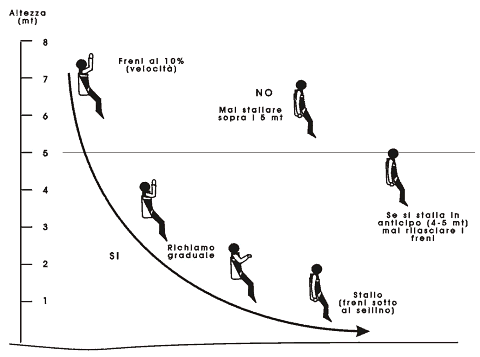
Figura 6-13. Limiti di altezza per effettuare lo stallo finale in atterraggio: mai abbassare completamente i freni (o rallentare eccessivamente) al di sopra di 5 metri dal suolo.
|
GIOCHI CON IL VENTO
Quando il vento sostenuto impedisce il normale svolgimento della giornata di campetto niente paura: è ugualmente possibile divertisi parecchio imparando, nel contempo, cose preziose . Stiamo parlando dei giochi con il vento il cui valore didattico è veramente notevole poichè consentono all'allievo di prendere confidenza con la vela in condizioni di assoluta sicurezza.
"Sentire" la vela sopra di sè è infatti un requisito indispensabile per volare con padronanza ed un ampio prato in pianura, battuto da un vento sostenuto e laminare, costituisce la palestra ideale per raggiungere questo obbiettivo (se il vento è turbolento, niente da fare).
Lo scopo del "gioco" è quello di mantenere la vela in volo sopra di sè in modo continuo e controllato, e l'esercizio è utile non solo per gli allievi, ma anche per chi ha appena cambiato vela e vuole saggiarne i tempi di risposta.
GONFIAGGIO "ROVESCIATO" DELLA VELA

Figura 6-14. Come impugnare elevatori anteriori e freni per il gonfiaggio "rovesciato".
|
Per poter gonfiare la vela in presenza di vento sostenuto è difficile (e a volte francamente impossibile) utilizzare la tecnica normale: quando la vela, alzandosi, si trova aperta dietro di noi la resistenza che oppone al vento è tale da "trascinarci" all'indietro nonostante tutti i nostri sforzi.
Giocando con il vento, dunque, è necessario girarsi verso la vela, facendo passare gli elevatori di una semiala sopra al capo (è molto importante abituarsi fin dall'inizio a girarsi sempre dalla stessa parte , in modo da evitare sorprese quando si utilizzerà questa metodica per decollare).
A questo punto si impugnano i freni e gli elevatori lasciando l'incrocio che si è formato tra il corpo e le mani: la mano destra impugna freno ed elevatore che vanno verso la parte dell'ala che resta alla nostra destra e la mano sinistra gli altri.
Buttandosi con il peso all'indietro (esercitando la forza sul sellino, più che sugli elevatori stessi) la vela si gonfia e tende a "strapparci" verso di essa, ma la posizione "rovesciata" consente di opporre molta più resistenza (come nel tiro alla fune) ed è quindi facile far giungere la vela sulla verticale.
Questa tecnica di gonfiaggio viene anche detta "speculare" o "alla francese".
Le vele più recenti ed allungate, se sollevte come appena descritto, mostrano la loro migliorata "performance" salendo sopra di noi con un giuzzo e generando portanza in modo improvviso e potente: con queste ali, per evitare di essere letteralmente strappati da terra, è necessario impugnare gli elevatori anteriori con una mano e quelli posteriori con l'altra; durante la salita (da 3/4 circa in su) sarà allora possibile rallentarla e renderla più dolce semplicemente "schiacciando" gli elevatori posteriori: solto dopo che è stata raggiunta la verticalità possono essere impugnati i freni come più sopra descritto.
STABILIZZAZIONE
Una volta sollevata la vela il problema è " tenerla lì ": almeno inizialmente ci sembrerà dotata di una maligna tendenza a ricadere al suolo.
Disponiamo di tre strumenti per riuscire nel compito: gli elevatori anteriori, i freni e gli elevatori posteriori.
- Gli elevatori anteriori , che usiamo per il gonfiaggio, devono essere ripresi e trazionati ogni volta che la vela scende davanti a noi (ricordiamo che siamo girati) tendendo a trasportarci con sè.
- I freni verranno mantenuti in una posizione tale che la velocità della vela sia uguale a quella del vento, ed essa non tenda quindi nè ad avanzare nè a retrocedere (è dunque evidente che l'azione sui freni varierà, sia pur di poco, in modo continuo, al variare della velocità del vento). Se la vela ci passa sopra, viaggiando controvento, dovremo azionare i freni e fare uno o due passi all'indietro; se la vela tende a cadere, prima di riprendere gli elevatori anteriori, potremo provare a lasciare completamente i freni, per recuperarne la verticalità.
- Gli elevatori posteriori (che hanno lo stesso effetto dei freni, ma più potente) sono la nostra "sicurezza": tirandoli con energia la vela cade e si sgonfia. Se una folata particolarmente robusta trascina la vela sul prato e noi con essa, una energica trazione sugli elevatori posteriori la farà chiudere e, quindi, arresterà la sua e nostra corsa. Questa manovra si potrà rivelare preziosissima in decollo, quando essere trascinati dalla vela potrebbe non essere altrettanto innocuo.
Un secondo modo per ridurre drasticamente la resistenza offerta dalla vela, ed evitare quindi di essere trascinati, è attuabile con i modelli dotati di tre distinti elevatori per lato (quelle cioè che, oltre agli elevatori anteriori e posteriori, hanno anche quelli centrali , detti "b"); è allora sufficiente trazionare questi ultimi perchè la vela si ripieghi a V lungo tutta la sua lunghezza, senza più offrire alcuna resistenza.
Il trazionamento degli elevatori centrali viene anche utilizzato, in volo, quando si desidera incrementare il tasso di discesa per "sfuggire" ad ascendenze rivelatesi troppo robuste (stallo "b"): anche in questo caso, prima di imitarli, vale pena di interpellare i costruttori od i rivenditori, per sentire se esistono controindicazioni alla manovra.
Nel caso la vela si storti (una semiala alta ed una che tende a tornare al suolo) è necessario frenare l'ala alta e trazionare l'elevatore anteriore di quella bassa: una ampia azione di freno, inoltre, impedisce alla vela di "ruotare su sè stessa", costringendola ad adagiarsi al suolo nella giusta posizione.
IL "TRUCCO": ANTICIPARE LA VELA
Ci si accorgerà rapidamente che l'unico modo per controllare perfettamente la vela è quello di individuare rapidamente le tendenze "destabilizzanti" e di anticipare le correzioni. Il principio, fondamentale anche nel volo, è il seguente: più precocemente si interviene con una correzione, minore questa deve essere e maggiore sono i sui effetti stabilizzanti .
Ecco che i neofiti, quando giocano con il vento, si trovano sempre in posizioni estreme (letteralmente appesi agli anteriori, oppure con uno od entrambe i freni completamente tirati), mentre l'istruttore si limita ad osservare la vela dando, qua e là, impercettibili colpetti: la sua vela è completamente immobile (sembra disegnata) mentre quelle degli allievi ricordano fogli di carta in una tromba d'aria.
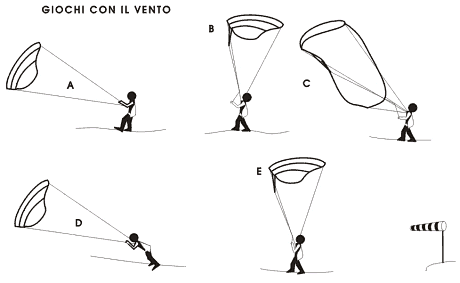
Figura 6-15. Giochi con il vento: A=la vela cade: trazionare gli elevatori antieriori; B= la vela ci sopravanza: frenare; C=un lato si alza: trazionare il freno; D=veniamo trascinati: trazionare gli elevatori posteriori; E=obbiettivo raggiunto.
|
|
BACK ______________________________________________________________________NEXT |
|