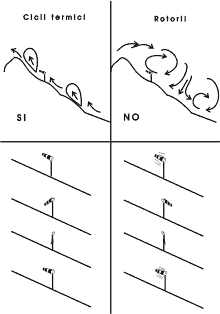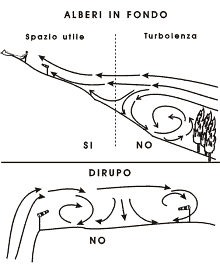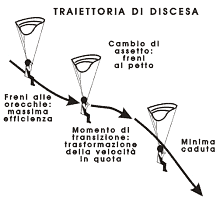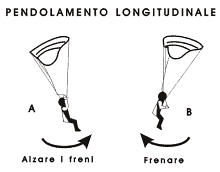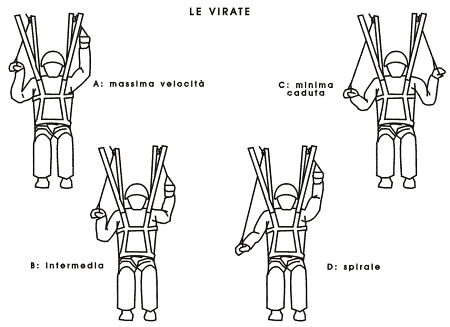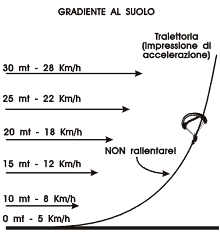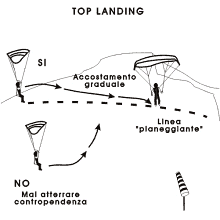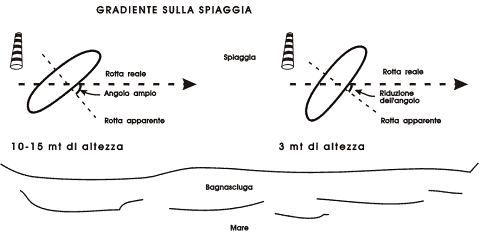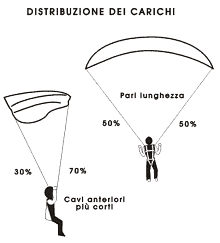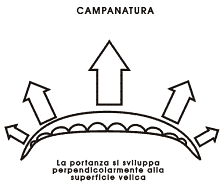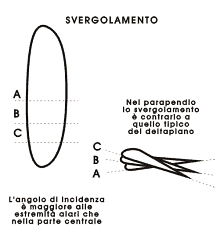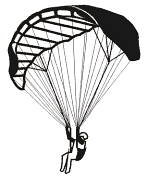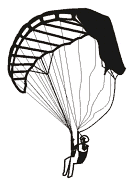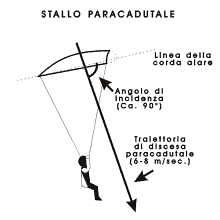|
VOLI ALTI
DECOLLO
Se l'errata valutazione delle condizioni meteo rappresenta la causa più frequente di incidenti, la scelta di un decollo "che non perdona" è sicuramente la seconda, e questo è particolarmente stupido perchè il parapendio si distingue dagli altri mezzi volanti proprio per la possibilità di "abortire" decolli fino a che si è stufi, posto, naturalmente, di aver scelto un terreno idoneo.
Deve quindi trattarsi di un prato in discesa, con una lunghezza sufficiente a "sbagliare" non uno, ma due o tre decolli a fila.
La zona deve inoltre essere la più aperta possibile in modo che il vento, non incontrando ostacoli, ci investa in modo lineare.
Bisogna diffidare dei decolli costituiti da una striscia di terreno (sia pur larga 25-30 mt) compresa tra due filari di alberi; in queste condizioni una componente laterale del vento genera una discendenza lungo tutto il corridoio. La pendenza dovrebbe essere almeno doppia rispetto alla linea di discesa dell'ala (ideale tra i 25 ed i 35 gradi).
LA PENDENZA ED I FRENI
Esiste una relazione precisa tra pendenza del terreno di decollo ed entità della trazione sui freni: più il decollo è ripido, più bisogna frenare (stando sempre, ovviamente, lontani dalle condizioni di stallo); cerchiamo di capire perchè.
Quando si corre in discesa ci si muove, contemporaneamente, sia in avanti che in basso ma i due movimenti hanno effetti molti diversi sulla vela.
In pianura, quando il movimento è solo in avanti, la vela è completamente "scarica", cioè non è chiamata a portare anche parte del nostro peso: non solo non si deve frenare ma, spesso, è indispensabile, correndo, mantenere una spinta sugli elevatori anteriori. Man mano che la pendenza aumenta, ogni nostro passo in avanti ci fa anche scendere e questo movimento verticale "carica" la vela di una parte del nostro peso (per assurdo, su un burrone, un solo passo carica la vela dell'intero nostro peso).
Come ben sà chi ha studiato l'aerodinamica, esiste una relazione tra carico e velocità di volo, per cui, caricando la vela, questa tende a volare tanto più velocemente quanto maggiore è il carico.
Se la pendenza è piuttosto ripida e non freniamo a sufficienza, la vela, dopo esser giunta sulla verticale, accelera, ci sorpassa ed il bordo anteriore si chiude, abortendo il decollo.
Per lo stesso motivo, se un terreno di decollo ha due pendenze, una minore per il gonfiaggio ed una maggiore per il decollo vero e proprio, sarà necessario variare l'azione sui freni nel momento in cui si passa da una pendenza all'altra: solo in questo modo la vela sembrerà "incollata" sulla verticale.
D'altro canto, poichè frenando variamo l'angolo di incidenza, un decollo la cui pendenza sia di poco superiore a quella di massima efficienza richiederà che i freni vengano comunque mantenuti all'altezza delle spalle (posizione corrispondente, appunto, alla velocità di massima efficienza), altrimenti non potremo staccarci dal pendio.
IL VENTO
Come abbiamo già accennato anche il vento ha una notevole importanza nella fase di decollo; l'intensità del vento, infatti, modifica sensibilmente il modo di decollare, in termini di forza necessaria e velocità della corsa: ormai sappiamo bene che l'ideale sarebbe una brezza frontale di 10-12 Km/h, tuttavia non sempre è così.
In linea generale possiamo dire subito che lo "slancio" necessario per ottenere il gonfiaggio della vela è inversamente proporzionale alla velocità del vento: vediamo i diversi casi.
VENTO ZERO
In assenza di vento siamo noi a dover fornire alla vela tutta l'energia richiesta per il suo gonfiaggio. Questo significa che dovremo fare uno o due passi indietro per prendere lo slancio ed iniziare una corsa energica trasferendo la massima velocità possibile agli elevatori anteriori. Una volta gonfiata la vela, la si verifica a vista , sempre continuando a correre, e si prosegue poi la corsa fino al raggiungimento della velocità minima di volo (circa 20 Km/h).
VENTO DA DIETRO
Con il vento che arriva da dietro NON SI DECOLLA! . Se siete su un ampio e morbido pratone, senza rocce o brusche pendenze, potete (a differenza dei vostri colleghi deltaplanisti) togliervi lo "sfizio" di verificare se è vero: vi renderete conto, in tal modo, che la teoria e la realtà vanno molto d'accordo in questo caso, e vi fermerete alcuni metri più avanti, idealmente dopo un bel ruzzolone. Lo stesso tentativo su un decollo "cattivo" (rocce, brusche pendenze) potrebbe invece avere esiti assai peggiori.
VENTO IDEALE (5-10 Km/h, frontale)
In questo caso non è necessario alcuno slancio, ma sarà sufficiente iniziare una corsa progressiva dopo aver posto in lieve tensione i cavi già sapendo che, nel momento in cui l'ala si gonfierà, opporrà una certa resistenza che causerà un momentaneo rallentamento. L'attimo del rallentamento è ideale per effettuare il controllo a vista della vela . Una leggera corsa, la giusta trazione sui freni, ed il pendio si stacca dolcemente.
VENTO MODERATO(15-25 Km/h, frontale)
L'energia necessaria per il gonfiaggio è completamente fornita dal vento e non è quindi necessario alcuno slancio, anzi ... in queste condizioni è sufficiente porre in lieve tensione i cavi anteriori, inclinando anche un po' il corpo in avanti.
Non appena il vento investe le bocche, l'ala si gonfia da sè. Specie per le velocità superiori (20-25), dovremo anche attenderci di essere, per qualche attimo, "tirati all'indietro": il pilota esperto, che lo sa, anticipa tale effetto facendo addirittura uno o due passi all'indietro lui stesso, approfittandone per controllare a vista la vela; in questo modo, anzichè essere lei ad avanzare fino alla nostra verticale, siamo noi che indietreggiamo per porci al di sotto della vela. Tentare di partire di slancio con un vento di questo tipo dà luogo ad un potente strappo all'indietro con sollevamento del pilota (che ricade qualche metro più a monte). Sempre con vento che oscilla sui 20 Km/h è anche possibile effettuare la partenza "rovesciata". Si procede come già descritto parlando dei "giochi con il vento" e, quando le vela è stabilizzata sul capo, si lasciano i freni, si compie una rapida giravolta (dalla parte giusta!), si riafferrando i freni (questa volta non incrociati) e ci si trova nella posizione giusta per decollare (dopo una rapida ma attenta occhiata alla vela).
VENTO TESO
Quando il vento supera i 25 Km/h, i margini di sicurezza si assottigliano notevolmente (indispensabile il decollo "rovesciato"), per scomparire al di sopra dei 30-35, condizioni nelle quali è meglio dedicarsi ad altre attività.
I CICLI TERMICI DI PENDIO
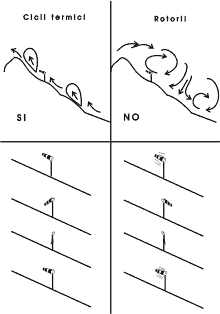
Figura 6-16. È molto importante saper distinguere con sicurezza i cicli termici di pendio da eventuali rotori di sottovento.
|
Come più ampiamente spiegato nel capitolo di meteorologia, quando l'aria è instabile, dal pendio riscaldato si staccano bolle che vengono sospinte contro il pendio stesso. Attraversando la zona di decollo, queste si presentano come intermittenti rinforzi del vento. È utile riconoscere la presenza dei cicli termici di pendio poichè facilitano il decollo ed aumentano le possibilità di veleggiare senza perdere troppa quota.
È importantissimo tuttavia saperli distinguere con certezza da momentanei rinforzi dovuti alla presenza di rotori di sottovento che risalgono il pendio: in queste condizioni il volo è assolutamente proscritto! La prima indicazione per distinguere le due condizioni ci viene dalla verifica del vento prevalente; i rotori di sottovento si generano solo con venti prevalenti che investono la montagna da dietro (rispetto al punto di decollo).
Inoltre, tra un ciclo termico e l'altro, ci sono, è vero, momenti di relativa calma ma non compaiono mai fenomeni di discendenza che sono invece costantemente presenti tra un rotore e l'altro.
La raffica dovuta al ciclo termico è moderata e senza eccessive variazioni di intensità e direzione, mentre, nel caso di un rotore, la manica risulta tesa (vento più forte) ed estremamente incostante (Fig. 6-16).
In ogni caso, se (in tutta coscienza) avete dei dubbi nel distinguere le due condizioni significa che non avete ancora accumulato abbastanza esperienza per volare in maniera autonoma e dovete quindi interpellare qualche pilota esperto.
Se il dubbio permane e non vi sono piloti esperti disponibili ripiegate il parapendio e tornate a casa : è vero che forse state perdendo un buon volo, ma con maggiori probabilità vi state salvando da una brutta avventura.
ALBERI IN FONDO
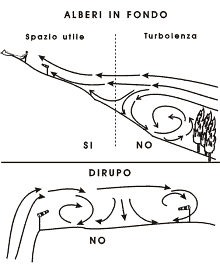
Figura 6-17. Gli alberi in fondo al terreno di decollo ne limitano la sfruttabilità, per le turbolenze che generano.
I decolli da strapiombo devono essere sempre assolutamente evitati.
|
La presenza di alberi a valle del decollo limita il terreno utile per la corsa, soprattutto per i fenomeni di turbolenza che si generano in presenza di vento (Fig. 6-17); lo stesso negativo effetto hanno le strade ed i tornanti nei confronti dei pendii sovrastanti.
STRAPIOMBO
Ottimo e rapido mezzo per ridurre l'eccessivo affollamento dei cieli. Scherzi a parte: non pensateci neppure . Anche in questo caso, infatti, non si tratta di abilità: lo strapiombo genera movimenti irregolari dell'aria che rendono molto probabile una "cattiva apertura" della vela, senza concedere alcuna possibilità di recupero (Fig. 6-17).
VERIFICHE PREVOLO
Dando per scontato che le condizioni meteorologiche siano idonee al volo, abituiamoci ad un controllo sistematico dell'ala e dell'attrezzatura prima di ogni volo : l'abitudine di eseguire i controlli in certo ordine (check- list) anche se può sembrare eccessivamente "pignola" aiuta a non tralasciare alcunchè, in momenti molto aggredibili dalla "distrazione" (emozione, impazienza, tensione).
Controlliamo dunque (in questo od in un altro ordine prestabilito):
L'imbrago: verifichiamo la tenuta delle cuciture (specie a livello dei gambali), lo stato delle eventuali funi o dei tiranti e la loro linearità, la chiusura del paracadute d'emergenza, se presente, verificando la forza necessaria per aprirla; controlliamo, inoltre, che non ci siano "giri".
Gli strumenti (se ci sono) : tariamo l'altimetro ed il variometro con un certo anticipo (avremo il tempo di effettuare eventuali correzioni che si rivelassero necessarie), proviamo la radio.
Gli indumenti : occhio al freddo!
La vela : ben distesa a ferro di cavallo, con le bocche centrali aperte.
I cavi : distesi, a vista, senza ingarbugliamenti.
I freni : distesi in esterno, a vista, senza ingarbugliamenti.
Dopo di che ci imbraghiamo ed attendiamo il momento buono per staccare; prima di farlo, tuttavia, verifichiamo (si, ancora!) gli ultimi aspetti importanti:
Vela : un'altra occhiata alla vela ci assicura che i movimenti di imbrago non l'abbiano spostata dalla posizione originale.
Cavi : dopo averli impugnati, solleviamo uno alla volta gli elevatori anteriori e verifichiamo che i cavi siano liberi fino al bordo di attacco; accertiamoci inoltre che gli elevatori posteriori poggino sulle braccia e non passino al di sotto di esse.
Imbrago : controlliamo che cosciali e pettorale siano correttamente chiusi e fermati.
Ostacoli : terreno libero, nessun altro pilota pronto per il decollo, zona antistante libera da piloti in volo.
Vento : frontale, lineare, di giusta intensità.
VIA
Specie ai primi voli è normale e giusto avere un poco di paura prima di un decollo: un po' di timore ci stimolerà a compiere ripetute verifiche e a mantenere una elevata concentrazione. L'esperienza insegna che bisogna piuttosto temere la eccessiva confidenza.
Non facciamoci mai prendere dalla smania di partire: scegliamo il nostro momento con calma e chiediamo sempre una verifica di massima ed una benevola occhiata a qualche pilota esperto presente. La sensazione che si possa perdere il "momento buono", specie all'inizio, è falsa e pericolosa: il momento buono è quando siamo pronti noi e solo allora.
IL VOLO
IL CONTROLLO DELL'INCIDENZA
Come abbiamo appreso dall'aerodinamica, il controllo dell'incidenza è cruciale nel determinare le due velocità di volo (verticale ed orizzontale) e, conseguentemente, anche l'efficenza (che esprime il loro rapporto). In attesa di approfondire meglio l'argomento (aerodinamica applicata al parapendio), semplifichiamoci la vita affermando che il controllo dell'incidenza viene effettuato azionando entrambe i freni in ugual misura.
Con i freni completamente rilasciati, l'angolo di incidenza è il minore possibile (trascurando volutamente la possibilità, rischiosissima con alcune ali, di trazionare gli elevatori anteriori per ridurlo ulteriormente).
Man mano che si tirano i freni l'angolo di incidenza aumenta fino a raggiungere quello di stallo (evento che si verifica, con la maggior parte delle ali, mantenendo i freni all'altezza del sellino).
LE VELOCITÀ DI VOLO
VELOCITÀ MASSIMA
Un parapendio, dunque, quando è lasciato a sè stesso (freni completamente rilasciati) vola alla sua velocità massima .
MASSIMA EFFICIENZA
Portando i freni all'altezza delle spalle si viaggia alla velocità di massima efficienza , quella cioè nella quale diviene ottimale il rapporto tra caduta ed avanzamento; in aria calma, è la velocità che ci permette di andare più lontano.
MINIMA CADUTA
Rallentando ulteriormente (freni all'altezza del petto), si ottiene la velocità di minima caduta : in aria calma e a parità di quota questa velocità è quella che ci permette di stare in aria più a lungo.
PRESTALLO
Mentre con altri mezzi volanti, un rallentamento anche lieve effettuato a partire dalla velocità di minima caduta porta allo stallo, con molti parapendio esiste la possibilità di assumere e mantenere una condizione intermedia (come trazione sui freni) tra le due, la velocità (ci sia consentito il termine) di prestallo .
In questa situazione (freni ulteriormente abbassati rispetto alla velocità di minima caduta) l'ala avanza pochissimo ma, in compenso, scende ad una velocità anche notevole (3-4 m/s e più).
STALLO
Tirate ancora e siete alla velocità di stallo : ciò che accade a questo punto dipende molto dal modello utilizzato, tuttavia l'ala smette di sviluppare portanza e quindi, in senso tecnico, non vola più.
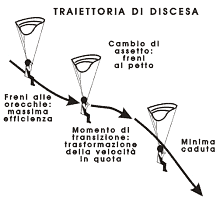
Figura 6-18. Il passaggio dalla velocità di massima efficienza a quella di minima caduta peggiora la traiettoria di discesa anche se, per qualche istante, si ha l'impressione opposta: questo fenomeno momentaneo è dovuto alla trasformazione della maggior velocità precedente in "quota".
|
Nella maggior parte dei casi la vela collassa (condizione chiamata da alcuni post-stallo ) e si scende in caduta libera fino a che non si riapre e vengono ripristinate le normali condizioni di volo.
Alcune vele reagiscono allo stallo, specie se indotto molto lentamente, entrando in una condizione nota come stallo paracadutale : la velocità di avanzamento è quasi nulla e quella di discesa è molto elevata, potendo raggiungere e superare i 6-8 m/s (vedi oltre).
VARIAZIONI DI VELOCITÀ E TRAIETTORIA DI DISCESA
Non è immediatamente intuitivo che, passando dalla velocità di massima efficenza a quella di minima caduta, la traiettoria di discesa divenga più ripida: quando si compie tale manovra, infatti, la sensazione è quella di venire addirittura "sollevati"; e allora?
Effettivamente, per qualche istante, la traiettoria si fa meno ripida: è il tempo durante il quale la nostra velocità precedente viene trasformata in quota (Fig. 6-18).
Dopo un attimo, però, stabilizzati sulla nuova velocità (più lenta) la traiettoria, effettivamente, si inclina maggiormente (se così non fosse quella attuale e non quella precedente sarebbe la velocità di massima efficenza).
ERRORI NEL CONTROLLO DELL'INCIDENZA E LORO RECUPERO
Anche se le vele utilizzate per la scuola sono in grado di recuperare, autonomamente e rapidamente, il normale assetto di volo, vale la pena di accennare alle manovre utili per accelerare tale processo. Una trattazione più dettagliata è fornita tra poche pagine, parlando delle chiusure e degli assetti inusuali.
PENDOLAMENTO
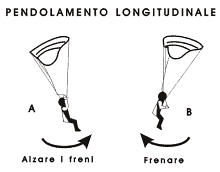
Figura 6-19. Per correggere un pendolamento longitudinale è necessario accellerare durante la fase A e, se non è sufficiente, rallentare durante la fase B.
|
Ve ne sono di due tipi: laterale e longitudinale.
Il pendolamento laterale , molto frequente durante le prime correzioni di rotta, consegue ad una o più sovraccorrezioni consecutive in virata (trazioni eccessive e prolungate dei freni); esso viene rapidamente smorzato dall'ala stessa, a patto che il pilota mantenga entrambi i freni a pari altezza (idealmente tra orecchie e spalle) per qualche secondo.
Il pendolamento longitudinale , che ricorda un "giro" in altalena, può derivare da correzioni brusche di incidenza (frenare bruscamente o rilasciare di colpo entrambi i freni) ma, più spesso, è il risultato della entrata o della uscita da bolle termiche. Mantenendo il paragone con l'altalena, possiamo distinguere due momenti rilevanti (Fig. 6-19) un momento di "risalita" ed uno di caduta in avanti.
Manovra di correzione : per fermare il pendolamento si deve accelerare la vela iniziando dal momento di verticalità per tutta la fase di risalita e, se questo non è stato sufficiente, frenare durante le fasi di ritorno. Sia pur un poco più lentamente, tuttavia, anche questo pendolamento viene smorzato ed annullato dalla stessa vela, posto che il pilota non intervenga inopportunamente.
POST-STALLO
Se entrambi i freni vengono abbassati completamente (all'altezza del sellino o più in basso) la vela stalla e, dopo qualche secondo, collassa. La drammaticità della situazione è direttamente correlata alla quota, dal momento che il recupero da una posizione di questo tipo determina la perdita di un'altezza considerevole (vedi la sezione "chiusure ed assetti inusuali).
LA VIRATA
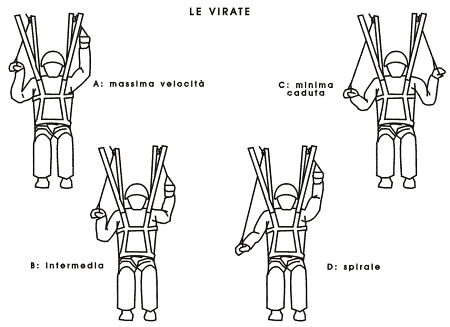
Figura 6-20. Posizioni in virata: si noti che in A, B e C la differenza di trazione sui freni non varia.
|
Come sappiamo, per effettuare una virata con il parapendio è sufficiente tirare un freno più dell'altro (maggior trazione del freno destro=virata a destra e viceversa). In altre parole ciò che determina la virata non è la posizione assoluta di un freno, bensì la differenza di trazione tra i due freni. Una piccola differenza (5-10 cm) determina una virata dolce ed ampia con scarsa inclinazione laterale (rollio), mentre una differenza maggiore (20-30 cm) produce una virata più accentuata con una inclinazione sensibile.
Con le prime ali, una differenza anche notevole tra i freni (uno rilasciato e l'altro al sellino) generava rapidamente una forte inclinazione, innescando facilmente una spirale positiva (vedi oltre), mentre con le vele moderne tale posizione, se assunta senza adeguata accelerazione, può innescare una vite, condizione estremamente critica (vedi sezione sulle chiusure e sugli assetti inusuali).
Il secondo elemento che gioca un ruolo importante nel determinare la rapidità di risposta e l'inclinazione dell'ala è, appunto, la velocità iniziale: come regola generale, tanto maggiore è la velocità iniziale , tanto più rapida è la risposta della vela e tanto maggiore l'inclinazione, a parità di differenza tra i freni.
Vediamo e commentiamo insieme alcuni esempi immaginando di mantenere costante la differenza tra i freni (diciamo pari a 20 cm) ma di trazionarli, entrambi, a differenti altezze.
VIRATA ALLA MASSIMA VELOCITÀ
Un freno è completamente rilasciato e l'altro è trazionato di circa 20 cm . È evidente che si può giungere a tale posizione da almeno due differenti condizioni di volo rettilineo e, dunque, distinguiamo i casi.
Partendo dalla massima velocità (entrambi i freni rilasciati) e trazionandone uno per 20 cm: l'ala risponde rapidamente, inclinandosi in modo evidente ed il raggio di curvatura sarà più stretto.
Partendo dalla massima efficenza (entrambi i freni trazionati di circa 20 cm) e rilasciandone uno completamente: l'ala risponde un poco più lentamente di prima, per la minor velocità iniziale, si inclina meno ed il raggio di curvatura è leggermente più ampio.
In entrambi i casi questa virata è idonea ad indurre cambiamenti di rotta precisi, anche se la velocità verticale è, tra i diversi tipi di virata riportati in seguito, quella maggiore.
VIRATA INTERMEDIA
Un freno all'orecchio e l'altro alla spalla (differenza sempre pari a 20 cm circa). La minor velocità da un lato aumenta il tempo di risposta e dall'altro riduce l'inclinazione dell'ala, rispetto alla precedente. Questa virata consente una minor perdita di quota ed è quindi utile per iniziare a sfruttare le correnti ascendenti, anche se non ancora ottimale in questo senso.
VIRATA DI MINIMA CADUTA
Partendo dalla velocità di minima caduta (freni all'altezza del petto o poco sotto) una mano sale e l'altra scende creando la solita differenza di circa 20 cm tra i freni.Come possiamo immaginare è la virata che consente la minor perdita di quota in assoluto ed è quindi quella ricercata dai veleggiatori provetti; essa richiede, tuttavia, una notevole sensibilità: come ricordiamo la velocità di minima caduta è, in volo rettilineo, molto prossima a quella di pre-stallo. Partendo da tale posizione, una trazione troppo brusca od eccessiva del freno può determinare unostallo d'ala (stallo asimmetrico) con conseguenze spiacevoli (se siamo vicini al costone montano od al suolo anche molto pericolose) ed il pilota esperto è pronto ad alzare entrambe i freni rapidamente quando inizia a percepire che l'ala "affonda".
ED IL PESO?
Con l'aumentare dell'allungamento dei parapendio, lo spostamento laterale del peso del pilota nel sellino ha iniziato ad esercitare un effetto evidente sulle virate (anche senza l'impiego delle sellette basculanti).
Similmente a quanto accade con il deltaplano, lo spostamento del peso del corpo a sinistra, caricando maggiormente gli elevatori di sinistra, induce un modesto rollio ed un'accenno di virata, senza che venga generata alcuna differenza nella trazione sui freni (anche su questi apparecchi è percepibile l'imbardata inversa). L'esperienza ha insegnato che è utile, in termini di rapporto tra raggio di virata e perdita di quota, accompagnare le virate di minima caduta con lo spostamento del proprio peso verso la parte interna della virata stessa.
DIFFERENZE DI RISPOSTA ALLA VIRATA
Negli esempi ora conclusi abbiamo immaginato di impiegare un'onesta ala di classe 1, ma la difficoltà vera nel descrivere il comportamento del parapendio in virata dipende dal fatto che i diversi modelli rispondono in modo anche molto differente a comandi di simile entità: per tale ragione è molto importante "saggiare" le risposte di una nuova ala con manovre inizialmente minimali e mai con comandi estremi .
In particolare un aspetto merita la nostra attenzione: l'inscindibile rapporto che esiste tra inclinazione, raggio di curvatura e perdita di quota.
Come ben sà chi veleggia, il segreto per sfruttare le ascendenze più deboli è quello di effettuare virate il meno inclinate possibile: in queste condizioni, infatti, il tasso di caduta è minimo ed aumenta all'aumentare dell'inclinazione. A differenza di quanto accade in altre discipline, con il parapendio l'inclinazione, data una certa differenza tra i freni, non dipende soltanto da noi, ma anche dal progettista della vela .
Le prime ali si inclinavano notevolmente anche per piccole differenze tra i freni, mentre quelle attuali rimangono "mirabilmente piatte" anche per differenze notevoli; evitate , tuttavia, di metterle in spirale troppo bruscamente o di compiere virate esasperate: proprio per la loro attitudine a non inclinarsi esse possono rispondere a sollecitazione estreme con uno stallo asimmetrico, "figura" tutt'altro che rassicurante di cui parleremo in maggior dettaglio tra breve (vedi).
ERRORI IN VIRATA E LORO RECUPERO
La estrema semplicità con cui si compiono le virate in parapendio rende molto difficile commettere errori gravi (escludendo, ovviamente, gli errori di traiettoria, come "centrare" un campanile e simili): se ci limitiamo a virate non estreme ed indotte gradualmente è semplicemente impossibile sbagliare.
Dal momento, però, che chi vola è spesso dotato di notevole fantasia, esaminiamo brevemente alcuni casi particolari rimandando una loro trattazione più completa nella sezione dedicata alle chiusure ed agli assetti inusuali (vedi oltre).
STALLO ASIMMETRICO (Stallo d'ala)
Sarebbe meglio chiamarlo stallo indotto da successive virate poichè in questo modo viene involontariamente provocato dall'allievo che, presa un poco di confidenza col mezzo, è completamente assorto nel tentativo di "galleggiare" il più possibile.
Egli si trova, quasi senza accorgersene, ad avere, semplicemente, entrambi i freni troppo bassi , indipendentemente dalla differenza tra loro. A questa condizione si arriva, tipicamente, dopo alcune virate e controvirate effettuate sempre abbassando ulteriormente ora un freno ed ora l'altro senza rialzare adeguatamente quello che controlla, di volta in volta, l'ala esterna. In alternativa risulta dall'abbassamento di un freno effettuato volando molto lenti (con un angolo di incidenza elevato) e prossimi allo stallo.
È sufficiente riportare rapidamente entrambi i freni alle orecchie, pronti a controllare e smorzare i successivi oscillamenti. Se la correzione non interviene tempestivamente, la situazione, specie con le ali ad alte prestazioni, evolve in una vite negativa.
VITE NEGATIVA
Di questo assetto, decisamente preoccupante e da evitare assolutamente, parleremo estesamente tra breve. Basti dire che non viene eseguito nemmeno nell'ambito dei corsi di Sicurezza in Volo, rivolti a piloti esperti ed eseguiti in condizioni di massima sicurezza (vedi).
CHIUSURA LATERALE
L'afflosciarsi di alcuni cassoni dell'ala esterna durante una virata può derivare da un errore estremamente diffuso: lasciare completamente scaricato il freno esterno (magari desiderando accellerare la virata) in presenza di turbolenze anche lievi. Specie con le vele più allungate, mantenere una moderata compressione dell'ala esterna è un sistema eccellente per "prevenire" tali sgraditi fenomeni.
AVVICINAMENTO ED ATTERRAGGIO
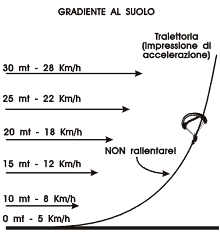
Figura 6-21. Il gradiente di vento al suolo può trarre in inganno, inducendoci ad un eccessivo (quanto rischioso) rallentamento in prossimità del terreno. La soluzione: sentire la velocità di volo con le orecchie, anzichè valutarla con gli occhi.
|
Una volta presa la decisione di atterrare, si lascia la zona di volo per portarsi sull'atterraggio: naturalmente sapremo già quale circuito è in uso o, se siamo gli unici in volo, quale circuito abbiamo deciso di adottare in base alle condizioni del vento e dell'atterraggio (vedi).
Anche se la manovra di atterraggio vero e proprio non è diversa da quella appresa sul Campo Scuola, dopo un volo alto esistono alcuni fattori nuovi che, se ignorati possono generare almeno due errori che è possibile (e doveroso) evitare.
GRADIENTE DI VENTO
Come sappiamo, vicino al suolo il vento viene rallentato, nella sua corsa, dall'attrito con il terreno, generando, per un'altezza di alcuni metri (anche 20 o 30) un sensibile gradiente di vento. Il pilota che ignora questo fatto e che scorda di valutare la velocità "con le orecchie" ed in base alla posizione dei freni anzichè "vederla con gli occhi", potrà avere l'impressione di accelerare notevolmente e potrà quindi rallentare troppo la vela, giungendo alla velocità di pre-stallo (alto tasso di caduta) o, peggio, determinare uno stallo vero e proprio, rovinoso vista la bassa altezza.
Un sistema semplice per garantirsi da questo, tuttavia, è quello di non abbassare mai i freni oltre l'altezza delle spalle durante il finale .
Il gradiente di vento esercita un effetto anche sulle due ultime virate nell'avvicinamento a U: la semiala più alta riceverà infatti più vento, causando una tendenza a "raddrizzare" la virata.
MANCATO ALLINEAMENTO CON IL VENTO
L'importanza di allinearsi contro vento dipende, in primo luogo, dalla intensità del vento stesso: è assurdo rischiare di perdere completamente l'assetto di volo, tentando virate "raso-suolo" (con consequenti pendolamenti), per giungere perfettamente controvento quando la manica indica una debolissima bava. Molto meglio effettuare lo stallo finale con un buon assetto, anche se non esattamente allineati.
Se invece una folata di vento improvviso ci sospinge da dietro ed è oramai impossibile invertire la rotta, teniamoci pronti ad una buona corsa e tentiamo di annullare, se non altro, la velocità verticale. Per fare questo è necessario acquisire velocità (freni rilasciati) ed attuare una richiamata progressiva ma molto decisa a circa 2 metri di altezza.
TOP LANDING
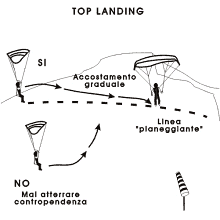
Figura 6-22. Il Top Landing deve essere effettuato individuando una linea "pianeggiante" (che taglia trasversalmente il pendio) priva di ostacoli.
|
Questo termine (letteralmente "atterraggio sulla cima") indica un atterraggio compiuto non necessariamente sulla vetta, ma anche su un pendio montano che consenta di decollare ulteriormente.
Per i piloti di deltaplano si tratta di una manovra impegnativa, che non tutti affrontano a cuor sereno o per puro divertimento. Con l'eccezione di alcune zone che sembrano "fatte apposta" (il mitico Monte Cucco è una di quelle) è infatti necessario che l'atterraggio avvenga "contro-pendio" e quindi a favore di vento (anzichè controvento).
Con il parapendio, la cui vela è sufficientemente distante dal pilota da non rischiare un prematuro contatto con il suolo, è invece possibile atterrare di traverso (e, fateci caso, su ogni pendio esiste sempre una linea trasversale perfettamente piana).
Ogni ampio decollo può quindi fungere anche da campo di atterraggio, posto che non vi siano rocce od alberi a renderlo pericoloso e, se la giornata consente di mantenere la quota o di guadagnarne, diventa allora possibile compiere più voli, intervallati da brevi soste ristoratrici.
L'avvicinamento viene fatto, dopo aver individuato la "linea di atterraggio", evitando di puntare direttamente alla montagna, ma accostandosi ad essa secondo una linea quasi parallela che ci avvicini gradualmente ; dovrebbe sempre essere possibile compiere una virata di 90 gradi verso valle per riprendere il volo senza problemi se le condizioni sono meno che ottimali (vento troppo sostenuto, turbolenza, ecc.)
L'atterraggio avviene normalmente ma, specie in presenza di vento, la perfezione vorrebbe che, un istante prima di toccare terra, lo stallo di arresto fosse leggermente asimmetrico, in modo che la vela si giri controvento nell'esatto momento in cui si atterra.
Mentre solo la pratica potrà perfezionare quest'ultimo aspetto, bisogna sapere subito che è un grosso errore tentare di atterrare in salita: contrariamente alle impressioni, infatti, non sarà possibile correre per esaurire la velocità residua (che, grazie al vento di spalle non è certo bassa) e ci si incasserà malamente contro il pendio.
Con un vento dolce e laminare il top-landing è piuttosto semplice e può essere affrontato dopo il perfezionamento dell'atterraggio in pianura; per contro, in presenza di ascendenze termiche, a ridosso del terreno vi sono spesso notevoli turbolenze che rendono molto impegnativa (se non addirittura fortunosa) la manovra.
TOUCH AND GO
Dopo aver perfezionato il top-landing ed essere riusciti ad arrestarsi con la vela controvento, è possibile mantenerla in volo, fare alcuni passi e decollare di nuovo. Non vi sono davvero limiti a ciò che un pilota esperto può fare su un ampio e morbido pendio esposto ad un vento laminare: ad esempio può mantenere un certo carico sulla vela alleggerendo il proprio peso fino a pochi chilogrammi e fare ampi balzi. Ma attenzione! Tentare le stesse cose su un pendio scosceso, con sassi, alberi o, peggio ancora, rocce, è invece decisamente pericoloso e deve essere assolutamente evitato. Ancora una volta siamo chiamati a discriminare con intelligenza, per mantenere i margini di sicurezza sempre ai massimi livelli.
ATTERRAGGIO IN ACQUA
Gli atterraggi in acqua sono da considerare potenzialmente pericolosi , a meno che siano stati previsti e che, oltre ad un pronto recupero con barca a motore, il pilota sia stato fornito di opportuni presidi galleggianti.
Capita invece che qualcuno "finisca in acqua" per errore, avendo previsto di atterrare sulla spiaggia. Questa evenienza, meno rara di quanto possa sembrare, può dipendere dalla cattiva valutazione del gradiente del vento che, sulle spiagge, ha un'effetto ancora maggiore (comunque, più negativo) rispetto agli atterraggi nei prati. Sulla spiaggia, infatti, il vento è in genere laterale, proveniendo dal mare; ecco quindi che, per volare sulla verticale della spiaggia, dovremo tenere una rotta più o meno rivolta verso il mare (per contrastare la deriva dovuta al vento stesso). È evidente che, se il vento cala (come accade avvicinandosi al suolo per il già citato gradiente) quello stesso angolo che prima ci permetteva di avanzare "sopra" la spiaggia, può risultare eccessivo, e farci finire in acqua.
Atterrare sulla spiaggia in presenza di vento significa quindi correggere l'angolo di deriva, man mano che il gradiente fa sentire i suoi effetti.
Se l'ammaraggio è indispensabile, la cosa più importante sarà liberarsi dall'imbrago; ancora in volo inizieremo ad aprire il pettorale , poi ci concentreremo sullo stallo finale, che dovrà essere leggermente anticipato in modo da far fermare la vela dietro di noi e non sulla verticale (in acqua non si possono fare passi in avanti).
Fatto questo ci si libera dai cosciali e si esce dall'imbrago : solo dopo tale operazione si potrà pensare, se immediatamente possibile, a recuperare anche la vela.
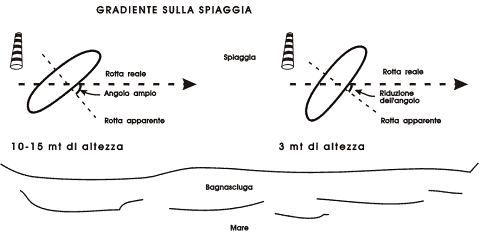
Figura 6-23. Il gradiente di vento su una spiaggia ha il perverso effetto di "attirare" la vela verso l'acqua: per evitare ciò si deve ridurre l'angolo di deriva man mano che ci si avvicina al suolo.
|
AUTOSTABILITÀ, CHIUSURE ED ASSETTI INUSUALI
Ci occuperemo, in questa ultima sezione dedicata al parapendio, ad esaminare alcuni aspetti peculiari di questo mezzo, fornendo un'interpretazione aerodinamica di ciò che accade.
Iniziamo proprio dall'analisi delle principali differenze tra l'ala "molle" e le ali rigide per quanto riguarda l'immissione ed il mantenimento delle virate.
Vedremo poi i meccanismi preposti al mantenimento dell'autostabilità del mezzo (condizione indispensabile perchè un velivolo possa librarsi in sicurezza) per concludere con una rassegna di quegli assetti che, un tempo, venivano semplicemente definiti chiusure e che hanno, invece, ricevuto sufficiente attenzione ed analisi da poter essere, in qualche modo, standardizzati.
COME VARIANO LE FORZE IN VIRATA?
La prima, evidente, differenza che si riscontra tra il parapendio e gli altri veleggiatori è la notevole distanza che esiste tra il baricentro dell'insieme ala+pilota (che coincide, in pratica con il pilota stesso) ed il centro di spinta, situato nella zona centrale dell'ala stessa: tale distanza è superiore alla lunghezza totale del mezzo!
Come vedremo, proprio questa caratteristica, che fornisce la principale base per l'autostabilità, influenza anche le forze in virata; cerchiamo di immaginare come.
Durante il volo rettilineo le quattro forze fondamentali si oppongono a due a due, e la distanza esistente tra baricentro e centro di spinta è responsabile della tendenza al pendolamento longitudinale.
Azionando un freno la semiala interna rallenta (l'ala tende ad imbardare) e nel frattempo si inclina: siamo in quella condizione che, senza una cabrata, dovrebbe determinare la scivolata d'ala. Invece accade qualcos'altro (visto che, con rarissime eccezioni, nessuno cabra e pochi scivolano): verosimilmente accade che il brusco rallentamento della semiala, determina un rallentamento della velocità media dell'intiera ala mentre il pilota (appeso 4 o 5 metri più sotto e dotato di inerzia assai maggiore, perchè più pesante) tende a proseguire dritto per la sua strada. I cavi si tendono e la "deviazione" di traiettoria che impongono al pilota non innesca un pendolamento longitudinale, perchè l'ala stessa è inclinata: la deviazione genera invece una forza centrifuga, che viene notevolmente amplificata dalla distanza.
Semplicemente mantenendo la stessa posizione dei freni (e anche questo è molto anomalo in aeronautica dove, in virata, i timoni sono perfettamente centrati e simmetrici) la maggior resistenza che la semiala interna continua ad opporre alimenta la forza centrifuga e mantiene "coordinata" la virata stessa.
Al momento di riprendere una traiettoria rettilinea il riallineamento dei freni, facendo cessare la maggior resistenza dell'ala interna, determina un'imbardata "raddrizzante", e conferendo ugual portanza ad entrambi le semiali determina la orizzontalizzazione. Senza la necessità di compiere alcuna manovra particolare il pilota (sul quale ha smesso di agire la forza "deviatrice" e quella centrifuga) ritorna sotto la verticale dell'ala, obbedendo alla legge di gravità.
AUTOSTABILITÀ
Con il termine AUTOSTABILITÀ si intende la capacità dell'apparecchio di riacquistare autonomamente (e mantenere) un assetto di volo rettilineo (in condizioni di aria calma), nonchè la capacità di opporsi a manovre tendenti a turbare tale assetto, in maniera tanto più forte quanto più esasperata è la manovra.
Anche il concetto di stabilità ruota intorno ai tre assi che individuano i possibili movimento nello spazio.
STABILITÀ LONGITUDINALE (SULL'ASSE TRASVERSALE):
Un ala stabile longitudinalmente è un ala che reagisce alle picchiate "tentando" di cabrare, ed alle cabrate "tentando" di picchiare.
Se si considera che, nel parapendio, la velocità di trim (cioè la velocità che l'ala assume in assenza di interventi da parte del pilota) coincide con quella di massima velocità (nessuna azione sui freni) allora l'apparecchio risulta longitudinalmente stabile, ma soltanto entro limiti ben definiti .
Infatti, partendo dalla posizione di trim e frenando, si deve esercitare uno sforzo tanto maggiore quanto più si frena (chiaro segno dell'opposizione autostabilizzante dell'ala). Questo fatto, però, è progressivo ma non continuo: ad un certo punto, superata la posizione di stallo, la vela si chiude e non si oppone più alla nostra trazione sui freni.
È stato superato un limite di autostabilità.
Anche la manovra opposta dà risultati simili, ma con un'escursione molto minore: partendo dalla velocità di trim ed esercitando una trazione sugli elevatori anteriori, si osserva una ulteriore accelerazione e, contemporaneamente, una forte opposizione alla trazione stessa. Aumentando ulteriormente la trazione il bordo di attacco, si chiude (collasso simmetrico) e gli elevatori non offrono più alcuna resistenza. È stato superato l'altro limite di autostabilità.
In pratica, quindi, il parapendio è longitudinalmente autostabile in una gamma ben precisa di assetti e di velocità, gamma che non deve mai esser essere superata (mai trazionare gli elevatori anteriori, mai portare i freni al sellino durante il volo).
Bene, con quale meccanismo viene garantita questa, sia pur limitata, autostabilità?
Con il meccanismo del bilanciere.
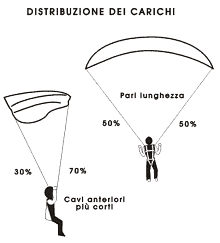
Figura 6-24. La distribuzione dei carichi dipende direttmente dalla lunghezza dei cordini.
|
In primo luogo bisogna dire che vela e pilota (i due elementi in gioco) hanno caratteristiche cosi differenti (uno tozzo e pesante, l'altra ampia e leggerissima) che tendono a disporsi in posizione verticale (allineati, cioè, alla forza di gravità e con i cavi in trazione) anche con la vela collassata: è questa la realtà fisica che stà alla base dell'apertura dei paracadute da lancio e d'emergenza; il pilota libera la vela che, ancora accartocciata, tende comunque a cadere più lentamente, dandogli l'impressione che si allontani celermente verso l'alto; man mano che il tessuto si dispiega offre una resistenza sempre maggiore e, se non vi erano errori di ripiegamento, si apre con un gran botto, consolidando definitivamente la verticalità tra ala e pilota.
Questo fenomeno da solo non può essere propriamente definito "autostabilità longitudinale", ma costituisce la base, il requisito preliminare, di quest'ultima, perchè permette di considerare il pilota come se fosse semplicemente appeso ad un corpo posto sopra di esso.
A questo punto interviene il meccanismo del bilanciere. L'angolo di incidenza dell'ala in volo (a freni rilasciati) dipende infatti dalla lunghezza relativa dei cavi anteriori e di quelli posteriori, nonchè dal disegno del profilo alare: nel parapendio tali lunghezze sono calcolate in modo che circa il 70% del peso del pilota gravi sugli elevatori anteriori ed il restante 30% su quelli posteriori.
In assenza di sollecitazioni questa distribuzione determina l'angolo di massima velocità.
Esercitare una trazione sugli elevatori posteriori, a questo punto, ha l'effetto di ridistribuire il peso del pilota fra cavi anteriori e posteriori a favore di questi ultimi: l'unico modo di spostare il carico, tuttavia, è quello di "appendersi" con le braccia agli elevatori ed il numero di chili "spostati" dipende esattamente dalla forza con cui ci "appendiamo". Qualche chilo di trazione corrisponde a qualche chilo "spostato" dai cavi anteriori ai posteriori; è quindi abbastanza evidente che esiste una proporzionalità tra entità dello sforzo da compiere ed effetto: maggiore l'effetto maggiore lo sforzo, il principio dell'autostabilità.
Il discorso non cambia considerando l'ipotesi di "appendersi" agli elevatori anteriori ma, visto che questi portano già il 70% del carico, non possiamo attenderci di caricarli ulteriormente senza che la vela chiuda; al contrario è possibile caricare parecchio quelli posteriori e anche questo fatto è coerente con la normale tecnica di guida: tutte le manovre, nel parapendio, si riducono ad una maggiore o minore azione sui freni.
A proposito di freni ... nel nostro esempio abbiamo parlato di elevatori posteriori per semplificare la già complessa situazione ma, se è vero che si può pilotare un parapendio utilizzando questi ultimi, è anche vero che di solito si usano i freni.
STABILITÀ LATERALE (SULL'ASSE LONGITUDINALE):
Lo stesso ragionamento esposto prima vale anche per la stabilità laterale, con la differenza che, in questo caso, la lunghezza dei cavi è perfettamente identica e simmetrica: il risultato, ovvio, è che il pilota-peso si stabilizza al centro, con scarse possibilità di oscillare rispetto alla vela , dati i numerosi punti di aggancio. L'insieme vela-pilota può invece pendolare lateralmente ma, ancora una volta il peso-tutto-in-basso tende col tempo a smorzare le oscillazioni (proprio come accade a quel pupazzo gonfiabile detto "Bobo-sempre-in piedi" con cui molti hanno giocato da piccoli): si tratta dunque di una condizione tendente alla stabilità.
È invece totalmente impossibile (oltre che privo di senso), cercare la ragione della autostabilità laterale del parapendio considerando solo la vela e non il pilota: la sua campanatura, grossomodo assimilabile ad un diedro negativo, ne fa un'ala instabile per eccellenza; per questo, a differenza di quanto accade a volte con i deltaplani, non vedrete mai un parapendio "prendere il volo" senza pilota.
STABILITÀ ROTATORIA (SULL'ASSE VERTICALE):
La stabilità orizzontale deriva dal fatto che la linea di avanzamento "normale" è anche quella che offre di gran lunga meno resistenza: gli stabilizzatori e la campanatura, infatti creano immediatamente una notevole resistenza se l'ala tende ad imbardare. Inoltre, proprio per la presenza della campanatura, il vento relativo che giunge di traverso (come avviene, appunto, durante un'imbardata) investe il bordo d'attacco con angoli di incidenza diversi: questo rende differente il contributo dato dalle due semiali alla portanza con un effetto "raddrizzante". In alcune ali, infine, è evidente una certa "freccia" che contribuisce anch'essa alla stabilità rotatoria, come per altri veleggiatori.
PERCHÈ LA VELA RIMANE APERTA?
I meccanismi che mantengono aperta la vela sembrano essere almeno tre e tutti intervengono, in misura maggiore o minore, a seconda del "disegno" dell'ala e delle condizione di volo.
Pressione all'interno della vela : l'aria che entra dalle bocche gonfia la vela mantenendo, all'interno, una pressione uniforme grazie ai fori presenti sulle centine. Questo meccanismo è l'unico ad intervenire durante la fase di gonfiaggio, mentre durante il volo stabilizzato fornisce soltanto un (pur notevole) contributo. La pressione torna ad essere importantissima in caso di chiusura, come hanno rivelato le "difficoltà" di riapertura che gravano sulle ali con poche bocche o con bocche quasi chiuse (ad es. Trilair).
Forza aerodinamica totale : la forza aerodinamica totale, che si genera quando un profilo alare vola con angoli di incidenza compresi tra quello di massima velocità e quello di stallo, offre, durante il volo, un notevole contributo al mantenimento dell'apertura. Il suo effetto, come insegnano i diagrammi Cp e Cr, è maggiore agli angoli di incidenza maggiori, e si riduce notevolmente per piccoli angoli.
Ecco perchè un parapendio che vola alla massima velocità ha maggior tendenza a "subire" le turbolenze: al contrario, volando alla velocità di massima efficenza, si ottiene un ottimo compromesso tra compressione e forza aerodinamica totale; questa, infatti, è la velocità da tenere per minimizzare gli effetti delle turbolenze sull'ala (in altri termini, per minimizzare le possibilità di chiusure).
È vero che, rallentando ulteriormente, la forza aerodinamica totale tende ad aumentare, ma la compressione (su quasi tutti i modelli) invece si riduce, in modo che la somma dei due meccanismi è inferiore rispetto a quanto si ottiene alla velocità di massima efficenza.
Resistenza offerta dalla vela : mentre questo meccanismo è pressochè ininfluente nelle condizioni normali di volo, può addirittura divenire prevalente in casi particolari. Si pensi allo stallo paracadutale, quando non esiste la forza aerodinamica totale e la pressione dell'aria è minima: la vela resta aperta scendendo con un alto tasso di caduta. Non dimentichiamo che, in fondo, i già citati cupoloni rimanevano aperti esclusivamente per resistenza.
DISPOSITIVI ANTI-CHIUSURA
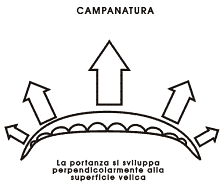
Figura 6-25. Effetto della campanatura sulla direzione delle "linee di portanza": si noti l'effetto di mantenere distesa la parte centrale.
|
Resta comunque il fatto che le ali attuali chiudono molto meno di quanto ci si potrebbe aspettare in base alle loro notevoli prestazioni: questo brillante risultato è stato ottenuto anche grazie ad almeno due "stratagemmi", che si oppongono alla chiusura o che accelerano le riaperture "spontanee": la campanatura e lo svergolamento (inverso rispetto a quello del deltaplano).
Mentre in un'ala "piatta", la forza aerodinamica che si genera nelle varie sezioni è sempre verticale (dal centro alle estremità alari) in un'ala "campanata" la forza aerodinamica è diretta "a raggiera". Questo fatto comporta alcuni vantaggi di stabilità:
- in primo luogo le estremità alari, "tirando" anche verso l'esterno contribuiscono a creare e mantenere una tensione trasversale nella vela stessa;
- nel caso si verifichi una chiusura frontale centrale, le due semiali, anzichè collassare verso il centro (come farebbero quelle di una vela "piatta") tendono a favorire la distensione, e dunque la riapertura della vela;
- nel caso, molto più frequente e meno preoccupante, di una chiusura laterale, il carico si ridistribuisce sulla parte di vela ancora gonfia ed il volo mantiene ugualmente una sua linearità, fintantochè la vela si riapre.
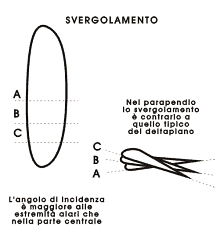
Figura 6-26. Lo svergolamento, presente su alcuni modelli di parapendio, aiuta la riapertura e rende più graduale lo stallo finale.
|
Lo svergolamento, cioè il differente angolo di incidenza che il bordo d'attacco presenta passando dalle estremità alari alla parte centrale, è complementare alla campanatura e ne favorisce le funzioni.
In condizioni normali di volo, infatti, le estremità alari hanno un angolo di attacco maggiore rispetto al centro. In tal modo una brusca riduzione dell'angolo di incidenza lungo tutto il bordo d'attacco (come accade entrando in una discendenza) riduce maggiormente la portanza nella sezione centrale (angolo di incidenza minore) rispetto alle sezioni laterali (angolo maggiore): queste ultime potranno dunque svolgere la funzione prima citata di "ridistendere" la vela.
Lo svergolamento, inoltre, rende anche più morbido e graduale lo stallo: infatti, proprio per il loro maggiore angolo di incidenza (e per il fatto che i freni agiscono prevalentemente su di esse), le sezioni laterali stallano prima di quella centrale che continua, ancora per qualche attimo, a generare portanza.
Nota: lo svergolamento "inverso" rispetto al deltaplano era una realtà nei primi modelli di parapendio. Le ali più recenti hanno abbandonato questo "stratagemma" e lo svergolamento è nullo o, addirittura, le estremità alari presentano un'incidenza inferiore (di 1 grado) rispetto alla parte centrale.
GLI ASSETTI INUSUALI 1
LE CHIUSURE E GLI ASSETTI INUSUALI
Le "chiusure" hanno sempre rappresentato una fonte di vivissima preoccupazione per chi si avvicina al volo col parapendio e, in effetti, lo stesso termine contrasta ed annulla quello molto più rassicurante di "paracadute" da cui "parapendio" evidentemente deriva. D'altro canto vi possono essere situazioni nelle quali si desidera aumentare il tasso di discesa: "chiudere" una parte della vela (in modo da ridurre la superficie portante) è un metodo che, dal punto di vista aerodinamico, non fa una grinza.
Col passare degli anni, col miglioramento progettuale delle vele ed assecondando il desiderio tipicamente umano di andare sempre un pò più in là, si è progressivamente ampliata la base di conoscenze su assetti di volo che possono senz'altro essere definiti "inusuali" e che sono, oggi, classificati in modo abbastanza preciso.
La chiara conoscenza, almeno teorica, di come si generano e di come possono essere prevenuti o risolti, costituisce un importante bagaglio di sicurezza per il pilota, sempre che non divenga, paradossalmente, uno stimolo a sopravvalutare le proprie possibilità ed a sottovalutare i rischi che derivano dal prendere "alla leggera" queste situazioni. Molti di tali assetti sono già stati superficialmente esaminati parlando degli errori nel controllo dell'incidenza e degli errori in virata; alcuni di essi, ed altri, possono però presentarsi anche "spontaneamente" in condizioni particolarmente turbolente (cioè quando l'errore compiuto non riguarda il pilotaggio ma la valutazione delle condizioni meteo in relazione alle proprie possibilità ed alla propria ala).
Vale dunque la pena di riesaminarli in modo più organico ed approfondito, premettendo alcuni punti fondamentali:
- La ricerca e l'esecuzione in volo di tali assetti sono un rischio puro (non controbilanciato, cioè, da importanti vantaggi), a meno che non vengano attuate nell' ambito di un corso organico di Sicurezza In Volo (SIV per gli addetti ai lavori), tenuto da istruttori qualificati ed esperti su questo tema. La serietà di un simile corso sarà anche deducibile dalle misure di sicurezza adottate (che debbono tassativamente comprendere un ampio specchio d'acqua sul quale fare le manovre, nonchè una barca attrezzata per l'eventuale recupero).
- Il paracadute di emergenza deve essere in piena efficienza (in realtà un corso SIV dovrebbe comprendere una prova pratica di impiego, prova che può rendersi prematuramente necessaria da errori compiuti durante i voli test).
- Poichè i comportamenti in volo, specie durante anomale sollecitazioni, variano anche notevolmente da parapendio a parapendio, non è lecito ritenere di saper eseguire una manovra indipendentemente dall'apparecchio utilizzato.
In effetti il principale obbiettivo di un corso SIV è quello di farci meglio comprendere gli effettivi limiti operativi del nostro mezzo: quando il mezzo cambia le prove di volo dovrebbero essere ripetute, sempre adottando le misure di sicurezza sopra citate.
UNA REAZIONE AERODINAMICA "COSTANTE"
Come vedremo, all'uscita da una chiusura o da un assetto inusuale corrisponde, nella maggior parte dei casi, una evidente tendenza della vela ad acquisire improvvisamente una forte velocità orizzontale; questo fatto deve essere opportunamente previsto e controllato, frenando.
La spiegazione aerodinamica è, questa volta, piuttosto semplice ed intuibile: quando l'ala riduce (od addirittura annulla) la propria portanza, la velocità verticale aumenta notevolmente. Non appena l'ala assume nuovamente l'assetto di volo, essa si trova improvvisamente "caricata" dal peso del pilota, moltiplicato dalla velocità verticale acquisita. Il profilo alare, nuovamente efficiente, reagisce all'aumento di carico nell'unico modo che l'aerodinamica gli consente: con un rapido aumento della velocità orizzontale (tendendo a schizzare in avanti).
Il pilota, tuttavia, dopo aver trasferito la sua velocità verticale alla vela, è ancora piuttosto fermo in senso orizzontale: l'ala incontra dunque nello stesso pilota un ostacolo all'avanzamento e, facendo perno su di esso, si abbassa rapidamente davanti a lui (nei casi più estremi il pilota può addirittura "cadere dentro" alla stessa vela, con evidenti problemi nell'azionare il paracadute d'emergenza).
Se la ripresa del volo, sempre partendo da una elevata velocità verticale, non avviene in modo simmetrico, soltanto una parte della vela riprende a volare, trovandosi a sopportare un carico ancora maggiore: la reazione di quella parte di vela si tradurrà, ancora una volta, in un rapido avanzamento della semiala che può innescare collassi di vario genere.
Morale : all'uscita da una chiusura o da un assetto inusuale è estremamente importante esser pronti a controllare l'impennata di velocità e le sue eventuali asimmetrie , agendo per tempo sui freni, fino al ripristino di un assetto di volo rettilineo e simmetrico. Ogni manovra di questo tipo comporta una notevole sollecitazione alla struttura.
UNA COSA DA TENERE A MENTE
Si vedono, a volte, allievi che "pompano" la vela sbattendo velocemente le braccia (che impugnano i freni) in su ed in giù, quasi ad imitare il volo del fringuello. Se vi capita di assistere ad un simile spettacolo, osservate il bordo di uscita: noterete che la convulsa manovra non produce alcun effetto visibile e questo perchè l'agitato pilota scorda l'inerzia legata alla trasmissione dei comandi. Dopo aver trazionato un freno (per qualsiasi motivo) è necessario attendere almeno un secondo (o più) perchè la vela si accorga del comando (in altri termini perchè lo "registri").
Per questo il freno può (ed in alcuni casi, come vedremo, deve) essere trazionato fino in fondo, ma sempre in modo progressivo e mai scompostamente o troppo celermente.
SMALTIMENTO DI QUOTA
Consideriamo dapprima alcune condizioni decisamente "artificiali" (che non si possono generare spontaneamente): la spirale picchiata, le orecchie e lo stallo "B"; si tratta di manovre che, per quanto non standard, offrono il vantaggio di aumentare il tasso di discesa senza esporre a rischi eccessivi (specie le prime due).
SPIRALE PICCHIATA
Considerazioni generali . Con i primi parapendio la spirale picchiata veniva utilizzata come sistema di discesa rapida in condizioni di ascendenza; oggi con apparecchi costruiti per girare limitando al minimo la perdita di quota, tale configurazione non è di certo la più adatta a raggiungere lo scopo.
Infatti le attuali prestazioni dei mezzi consentono una discesa rapida in spirale picchiata solo per valori molto alti di rollio e quindi sottoponendo la struttura ad un notevole sforzo ed il pilota ad altrettanto stress.
Considerazioni aerodinamiche . In spirale picchiata stabilizzata il carico alare e, di conseguenza, il fattore di carico, aumentano proporzionalmente all'aumentare dell'angolo di rollio. È chiaro che all'aumentare dell'angolo di rollio aumenta la forza centrifuga e quindi, di fatto, il peso totale, con conseguente aumento di tutte le velocità, sia quella di stallo che quella massima.
Ad angoli di rollio elevati si possono raggiungere, col parapendio, 3.5-4 G, valori inferiori ai limiti massimi di carico per un apparecchio nuovo, ma di tutto rispetto se si pensa che la soglia dell'oscuramento della vista inizia, nelle accelerazioni di tipo positivo, proprio a 4 G.
Induzione . Abbassare in modo graduale un freno inducendo una rotazione via via più veloce ed un rollio sempre maggiore; è necessario avere la pazienza di attendere la risposta dell'ala, che deve sempre mantenere una buona velocità (il rischio, ovviamente, è quello uno stallo d'ala).
Per facilitare l'innesco della spirale picchiata è consigliabile portare il peso del corpo all'interno della virata, tenendo conto dell'eventuale azione degli incroci sulla selletta; è anche possibile eseguire l'ingresso dopo alcune inversioni di rollio che accelerano il raggiungimento dell'inclinazione e della velocità necessarie.
Manovra di recupero . Così come nell'induzione, anche in uscita il comando deve essere rilasciato gradualmente, affinchè non si generino brusche derapate dell'ala.
Quando il sistema ha sfogato tutta la sua energia cinetica l'ala si troverà in una condizione vicina allo stallo dinamico, in relazione dell'angolo di rollio raggiunto. Essendo la ripresa caratterizzata da una picchiata dell'ala, il pilota dovrà esser pronto a frenarla, smorzando le oscillazioni.
Errori o rischi . Un affondo troppo deciso ed eccessivo del comando può provocare l'entrata dell'ala in vite piatta negativa; rollio e forza centrifuga devono svilupparsi gradualmente perchè l'ala possa mantenere, anche nella parte più interna della curva, una velocità superiore a quella di stallo. Un rilascio troppo brusco determina una derapata dell'ala molto marcata e la condizione di stallo dinamico viene raggiunta quando il pilota non ha ancora smaltito tutta la forza centrifuga: il probabile risultato è un collasso asimmetrico.
ORECCHIE (Chiusura bilaterale controllata)
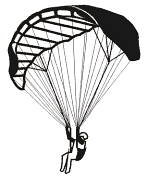
Figura 6-27. Le "orecchie" consentono un rapido smaltimento di quota in una configurazione relativamente stabile.
|
Considerazioni generali . È la contemporanea chiusura del bordo di attacco delle due estremità alari: si tratta di un metodo di discesa rapida (3-5 m/s) ampiamente utilizzato sulle ali allungate, poichè consente un discreto controllo dell'entità della chiusura e, quindi, della velocità di discesa, permettendo anche un minimo di manovrabilità. Anche l'uscita, se simmetrica, è poco traumatica e questo spiega la notevole diffusione della manovra.
Considerazioni aerodinamiche. La manovra determina una riduzione della superficie alare, "eliminando" temporaneamente dal gioco le due estremità: sulla parte restante grava l'intero carico ed aumentano, quindi, tutte le velocità (compresa quella di stallo!). Inoltre le modificazioni di forma dell'apparecchio ne riducono l'efficenza, aumentando ulteriormente la componente di discesa verticale rispetto all'avanzamento. L'azionamento dell'acceleratore consente di incrementare ulteriormente il tasso di discesa (fino a 8/10 m/s).
Induzione . Si tratta di far collassare, contemporaneamente, le due estremità alari richiamando verso il basso la corrispondente porzione del bordo d'attacco. In genere è sufficiente trazionare verso il basso un solo cordino per lato: quello che, partendo dalla bretella anteriore, raggiunge il bordo di attacco nella parte più esterna della vela. La manovra viene effettuata partendo dalla posizione di massima velocità (freni allentati, ma sempre impugnati) e non pone particolari problemi (i cordini sottili tagliano... quindi attenti se volate a mani nude).
La direzione di un parapendio con le "orecchie" può essere controllata dal pilota attraverso lo spostamento del proprio peso (dalla parte verso cui si desidera virare), ovviamente in modo meno rapido e preciso di quanto avviene, nel volo normale, utilizzando i freni.
Manovra di recupero . Lasciando andare i cordini prima trazionati potremo constatare se la nostra vela appartiene alla categoria di quelle che si riaprono spontaneamente dopo questa manovra, oppure se è una vela che "tiene le orecchie". Nel secondo caso sarà necessario affondare dolcemente qualche volta i freni, fino alla completa riapertura.
Errori o rischi . Una trazione asimmetrica condurrà ad una chiusura laterale (collasso asimmetrico - vedi); se la trazione si trasmette ad altri cevetti anteriori (ad esempio afferrando il cavetto centrale troppo in basso, vicino al moschettone) si può verificare una chiusura completa del bordo di attacco (collasso frontale - vedi), condizione decisamente più difficile da gestire.
STALLO "B"
Considerazioni generali . Lo stallo "B" prende il nome dalle bretelle intermedie (le "B", appunto) che bisogna trazionare per effettuarlo, ed ha in comune con lo stallo il drastico abbassamento, fino all'annullamento, della portanza (che consegue alla "distruzione" del profilo alare).
È un metodo molto efficace di discesa rapida e riveste dunque notevole importanza per la sicurezza (quando, per pericolo o necessità, si debba smaltire quota rapidamente); si tratta di un assetto che richiede l'intervento del pilota (non può verificarsi spontaneamente) e che, se male eseguito, può generare situazioni anche molto critiche.
Considerazioni aerodinamiche. Si tratta di una deformazione progressiva del profilo alare fino ad una sua scomparsa (quando il profilo stesso assume la forma di V, certamente non ha più niente di "alare"). Le prestazioni aerodinamiche calano di pari passo fino ad annullarsi: in queste condizioni il tasso di discesa si assesta sui 7-8 m/s in assenza di avanzamento. L'esecuzione dello stallo "B" e l'uscita da esso determina notevoli sollecitazioni alla struttura.
Induzione . Alzare le mani, mantenendo (ovviamente) l'impugnatura dei freni, fino ad afferrare le bretelle "B" (se possibile, infilare le dita tra le funi subito sopra i moschettoni, per poter garantire una manovra simmetrica), ed esercitare una progressiva trazione verso il basso. Poichè la posizione di partenza comporta una elevata velocità orizzontale (freni alzati), è importante esercitare la trazione gradualmente, permettendo una riduzione della velocità e, conseguentemente, riducendo al minimo il pendolamento di beccheggio dovuto all'inerzia del pilota.
La rottura completa del profilo alare coincide con un arresto (in senso orizzontale) dell'ala, che viene percepito dal pilota come una "caduta all'indietro". È importante mantenere la trazione sulle "B" fino ad una discesa stabilizzata; entro certi limiti, più si tirano in basso le "B", più la velocità verticale aumenta (dal momento che la superficie proiettata si riduce).
Manovra di recupero . L'uscita dall'assetto si effettua, quando si è ancora ad una quota di sicurezza, rilasciando simmetricamente e con decisione (specie nell'ultimo tratto) le bretelle, senza mai abbandonarle per evitare riprese al volo in modo asimmetrico. Come sopra accennato, l'ala reagisce al ripristino del profilo alare con un rapido avanzamento, che dovrà essere opportunamente contrastato dall'azione sui freni.
Errori o rischi . Il rilascio troppo lento delle "B" (specie nell'ultimo tratto) può causare l'entrata in stallo paracadutale stabile (vedi). Il rilascio troppo brusco od asimmetrico, può causare una rapida autorotazione dell'ala che a volte può tradursi in vite piatta negativa (vedi).
La "stabilità" dello stallo "B" è garantita dal mantenimento di un profilo a V lungo tutta l'ala: se la "cresta" centrale si rompe (eccessivo allargamento delle braccia) il bordo d'attacco può ripiegarsi in basso e si verifica un collasso simmetrico (vedi).
ASSETTI INUSUALI 2
CHIUSURA LATERALE (Collasso asimmetrico)
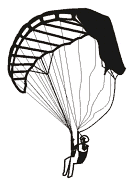
Figura 6-28. Chiusura laterale di media entità; non pone particolari problemi di recupero.
|
Considerazioni generali .La chiusura di qualche cassone laterale è un evento estremamente frequente e scarsamente pericoloso, grazie alle notevoli doti di stabilità delle ali moderne. Nei casi (più rari) che interessano una ampia superficie (fino a metà vela), è importante intervenire in modo corretto e tempestivo, soprattutto per contrastare pericolose autorotazioni.
Considerazioni aerodinamiche . Il collasso asimmetrico si verifica quando la semiala interessata, in condizioni di turbolenza, assume angoli di incidenza molto bassi o negativi. Il bordo d'attacco si ripiega su se stesso e la parte di ala retrostante si "sgonfia", collassando. Questo può verificarsi in turbolenza (entrando od uscendo da una termica) specie se si effettua una virata lasciando l'ala esterna completamente "scarica" (nessuna trazione sul freno esterno). Dopo la chiusura, le forze aerodinamiche generate dalle due semiali risultano squilibrate e si assiste ad una tendenza rotatoria (nelle ali attuali percepibile solo per chiusure piuttosto ampie) e ad un rollio verso il lato della chiusura. Il carico alare aumenta considerevolmente, così pure la velocità sulla traiettoria e la pendenza di quest'ultima. La velocità di stallo risulta considerevolmente aumentata.
Se si innesca un'evidente la fase di rotazione l'ala aumenta ulteriormente il proprio tasso di discesa e la propria velocità.
Prevenzione . Per evitare (o limitare) questo inconveniente è senz'altro utile mantenere sempre una certa trazione sui freni (anche su quello esterno rispetto alla curva) evitando di scaricare completamente una semiala. Inoltre è indicato, ai primi accenni di "sgonfiamento", aumentare il carico alare della semiala "a rischio", spostando da quella parte il peso del corpo. Attenzione, è importante sottolineare che la procedura di prevenzione è esattamente opposta a quella di recupero (da eseguirsi quando il collasso laterale si è già verificato).
Induzione . Esercitare una trazione decisa e a fondo di una delle bretelle "A" (destra o sinistra), impugnando, se possibile, in corrispondenza del moschettone, e rilasciare immediatamente. Entità e durata della rotazione dipendono dal disegno e dalle caratteristiche dell'ala.
Manovra di recupero . Chiusure modeste vengono recuperate autonomamente dall'autostabilità dell'ala, eventualmente aiutate da qualche trazione sul freno della parte collassata. Se la chiusura è più ampia e giunge ad interessare il 50% od oltre dell'apertura alare è necessario intervenire in modo tempestivo, anche se una certa rotazione è inevitabile.
Spostare il peso quanto più possibile dal lato della parte di ala ancora aperta, frenandola nel contempo per limitare la rotazione. L'azione sul freno deve essere graduale per evitare di mettere in stallo la parte che ancora vola (e che, ricordiamolo, sopporta l'intero carico).
Una volta arrestata la rotazione, agevolare la riapertura della semiala collassata trazionando in modo ripetuto il freno corrispondente.
Errori o rischi . Se si interviene prima con il freno, rispetto allo spostamento di peso, si rischia di mandare in stallo la semiala aperta; la maggior parte delle ali attuali è in grado di volare in modo accettabile anche con la metà della superficie velica: se la parte collassata si intreccia nei cordini generando la cosiddetta "cravatta", ricordiamo che il primo obbiettivo è quello di guadagnare un assetto stabilizzato e rettilineo con quello che rimane a nostra disposizione (spostamento del peso e freno). Successivamente si potrà intervenire trazionando i cavetti ingarbugliati o tirando, dal basso e dall'esterno, i cavetti che vanno agli stabilizzatori laterali.
CHIUSURA FRONTALE(Collasso simmetrico)
Considerazioni generali . La chiusura dell'intero bordo di attacco è una configurazione la cui pericolosità è più apparente che reale (posto che si disponga di sufficiente quota), dal momento che il parapendio tende ad un recupero spontaneo anche senza l'intervento del pilota.
Considerazioni aerodinamiche . Il collasso simmetrico si verifica quando tutta l'ala assume angolo di incidenza molto basso o addirittura negativo; quando il bordo di attacco si chiude, l'ala è decisamente meno efficiente, soprattutto per un repentino aumento della resistenza di forma. L'avanzamento dell'ala, dunque, rallenta considerevolmente e rimane indietro rispetto al pilota (che ha la sensazione di cadere e di venir tirato all'indietro) con conseguente variazione temporanea di assetto ed incidenza.
L'aumento dell'angolo di incidenza costituisce, al tempo stesso, un correttivo favorendo la riapertura.
Bisogna infine ricordare che, riducendosi la superficie portante, anche durante il collasso simmetrico si verifica un aumento del carico alare, relativo con aumento della velocità di stallo.
Prevenzione . È necessario evitare di farsi sorprendere ad angoli di incidenza troppo bassi (freni rilasciati) volando in condizioni di turbolenza od in uscita da una termica. Si deve inoltre evitare di lasciare che la vela avanzi troppo rispetto al pilota (fasi di recupero da altri assetti inusuali, eccessivi pendolamenti) anticipandone per tempo il rallentamento.
Induzione . Senza mai abbandonare i comandi, si esercita una trazione decisa ed a fondo sugli elevatori anteriori, in corrispondenza dei moschettoni, rilasciandoli immediatamente.
Manovra di recupero . La riapertura del bordo d'attacco, nei casi in cui non si completi spontaneamente, può essere agevolata trazionando entrambi i freni e rilasciandoli; è necessario tenersi pronti a frenare la vela non appena questa riassume il normale assetto di volo, per evitare le oscillazioni di beccheggio prima citate.
Errori o rischi. La trazione scomposta dei freni, oppure una successiva turbolenza, possono determinare una riapertura parziale, portando l'ala ad un collasso simmetrico anche esteso (vedi).
CHIUSURA CENTRALE CONTROLLATA (Corolla)
Considerazioni generali . La chiusura volontaria della parte centrale del bordo di attacco (con relativa forma a "corolla") viene da alcuni considerato un metodo di discesa rapida alternativo alle orecchie od allo stallo "B", nei riguardi dei quali, tuttavia, non offre sostanziali vantaggi. Inoltre alcune vele non accettano questa configurazione ed entrano subito in collasso simmetrico.
Considerazioni aerodinamiche . Come nel caso delle orecchie, la notevole riduzione di superficie portante determina un netto aumento del carico alare; inoltre la forma "alare" non proprio ortodossa, ha una efficienza decisamente modesta (quasi nulla). Ne consegue un netto incremento della velocità verticale ed una riduzione dell'avanzamento.
Induzione . Al contrario di quanto visto per l'induzione delle orecchie, si trazionano verso il centro ed in basso i cavi centrali delle bretelle anteriori (su alcune vele se ne debbono tirare 2 per parte) fino a determinare il ripiegamento della sezione centrale del bordo di attacco. L'aumento di resistenza ne determina un indietreggiamento rispetto alle estremità alari, che lo circondano fin quasi a congiungersi sul davanti.
Manovra di recupero . È sufficiente lasciare i cavi anteriori ed aumentare l'incidenza delle estremità alare esercitando una trazione simmetrica sui due freni.
Errori o rischi . Il rischio principale resta la rapida chiusura di tutto il bordo di attacco (collasso frontale) quando si induce l'assetto; tale chiusura può verificarsi, con alcune vele, anche effettuando la manovra prima descritta in modo "corretto".
STALLO D'ALA (Stallo asimmetrico)
Considerazioni generali . Lo stallo asimmetrico (stallo di una sola semiala) non è una configurazione stabile, bensì evolve, se non viene prontamente interrotto, in una vite piatta negativa, condizione decisamente critica (vedi).
Proprio per questo lo stallo asimmetrico deve suonare he, a volte, dura meno di un secondo.
Considerazioni aerodinamiche . Lo stallo di una semiala dà luogo, dalla parte stallata, ad un annullamento della portanza e ad un brusco aumento della resistenza, mentre l'altra semiala vola normalmente. Il parapendio, dunque, imbarda ed affonda verso la semiala stallata, innescando una rotazione sempre più rapida, che non può interrompersi se non vengono immediatamente rilasciati entrambi i freni.
Prevenzione . È un assetto di volo causato esclusivamente dal pilota, ed indica una scarsa conoscenza dei limiti operativi della propria ala. Tipicamente si verifica quando, volando molto lentamente (con un angolo di incidenza prossimo a quello di stallo) si affonda ulteriormente uno dei due freni (magari nel "tentativo" di sfruttare al massimo una ascendenza debole); su alcune vele, sempre volando al limite dello stallo, può essere sufficiente lo spostamento del peso del pilota. Come si vede, il rischio è limitato ai momenti in cui si vola prossimi alla velocità di stallo e la prevenzione consiste nel conoscere bene il proprio mezzo (tenendosi a distanza di sicurezza dai suoi limiti operativi) e, comunque, nell'acquisire sempre un poco di velocità prima effettuare le virate (ricordate di "osservare", ogni tanto, la posizione delle mani -e dunque dei freni-, poichè, immersi nel tentativo di "galleggiare ad ogni costo", si può perderne la percezione).
Induzione . In volo rettilineo, rallentare gradualmente fino alla velocità di "prestallo", quindi affondare ulteriormente un freno in modo da stallare l'ala interessata, rilasciando immediatamente entrambi i comandi e mantenendoli in una posizione intermedia. È importante tenere a mente che, durante la manovra, l'ala diviene incontrollabile, entrando in una rotazione accentuata.
Prima di poter effettuare qualsiasi ulteriore manovra è necessario che venga ripristinato il normale assetto di volo.
Manovra di recupero . Rilasciare prontamente e contemporaneamente entrambi i freni, mantenendoli (anche in assenza di trazione su di essi da parte della vela) all'altezza delle orecchie. L'ala effettua una rapida picchiata che è necessario controllare, frenando, per limitare l'oscillazione conseguente.
Errori o rischi . Attendere troppo nell'intervenire consente l'evoluzione a vite piatta negativa (vedi).
VITE PIATTA NEGATIVA(Stallo asimmetrico mantenuto)
Considerazioni generali . La vite piatta negativa si innesca come evoluzione dello stallo asimmetrico e, più precisamente, quando l'ala che ancora vola raggiunge un'elevata velocità angolare (cioè ruota molto rapidamente) "stabilizzandosi" in una rotazione rapida e continua.
Proprio per le sue caratteristiche (struttura "molle", notevole distanza tra baricentro e centro di spinta, cioè tra il pilota e la vela, numerosità dei cavetti) il parapendio è particolarmente vulnerabile allo stallo ed ancor più alla vite piatta, specie se questi si producono partendo da velocità relativamente elevate (alti valori di energia cinetica): l'esito è allora imprevedibile, poichè i ritardi del pilota rispetto all'ala possono tradursi in twist (torsione delle bretelle) od annodamenti con evidenti problemi di manovrabilità.
La vite negativa non controllata, e le configurazioni che la possono complicare, rappresentano una delle cause più frequenti di impiego del paracadute di emergenza.
Considerazioni aerodinamiche . In uno stallo asimmetrico mantenuto, la resistenza della semiala stallata è chiaramente molto alta ed il suo contributo al sostentamento praticamente nullo: essa diviene, pertanto, il perno di un sistema attorno al quale l'altra semiala, caricata dall'intero peso del pilota, ruota sempre più celermente. Un'elevata velocità orizzontale al momento dell'induzione, genera dei ritardi tra pilota ed ala, con disassiamenti verticali tanto più marcati quanto maggiore era l'energia cinetica iniziale.
Prevenzione . Valgono, ovviamente, le stesse norme esposte per lo stallo asimmetrico (che può essere considerato la fase iniziale, ancora ben correggibile, della vite piatta negativa).
La fase di stallo asimmetrico può essere estremamente breve o, addirittura inavvertibile, quando si compiono manovre che favoriscono l'evoluzione rapida in <-2>vite (manovre, cioè, che favoriscono l'alta velocità rotatoria della semiala non stallata): si deve dunque evitare di frenare eccessivamente un'ala rilasciando, contemporaneamente, il comando controlaterale.
Comunque, prima ancora che la vite, deve essere evitato lo stallo asimmetrico (cioè imparare a riconoscere i "messaggi" della propria vela).
Induzione . Nei corsi di SIV la vite piatta negativa, proprio per gli elevati rischi che comporta, non viene sempre effettuata: si considera infatti più utile imparare ad evitarla, inducendo e recuperando rapidamente uno stallo asimmetrico.
Manovra di recupero . Gli obbiettivi della manovra di recupero sono, sequenzialmente, due:a) arrestare la rotazione, rimettendo in volo l'ala stallata;b) controllare e smorzare le reazioni della vela ed i potenti oscillamenti che vengono a prodursi per l'elevata energia cinetica accumulata e per i disassiamenti tra vela e pilota.
Il primo punto è, apparentemente, il più semplice: è sufficiente alzare il freno della semiala stallata; non conviene, tuttavia, rilasciarlo completamente, altrimenti la semiala, riguadagnando improvvisamente portanza, accelera notevolmente e può superare ed "imbrigliare" l'altra. Come nello stallo asimmetrico, si devono portare i freni in una posizione intermedia, pronti a smorzare l'avanzamento e la rotazione verso il basso dell'intera vela. Per l'inerzia rotatoria del pilota, tuttavia, l'uscita non sarà mai lineare, ma si produrranno oscillazioni molto accentuate che debbono essere contrastate ed attenuate fino a riguadagnare un assetto di volo. Si deve inoltre scegliere il momento più opportuno per la manovra di recupero: il freno della semiala stallata dovrebbe essere rilasciato quando la vela si trova sulla verticale del pilota.
Dobbiamo comunque aspettarci un forte beccheggio che può evolvere in un collasso asimmetrico (vedi); nei casi più gravi il pilota può addirittura finire dentro la vela.
Errori o rischi . La vite negativa è già un errore, come abbiamo visto, piuttosto grave. Non attendere che il sistema si sia stabilizzato od eseguire interventi scoordinati ed intempestivi può causare l'abbattimento di sbieco dell'ala con possibilità che la stessa interferisca con la traiettoria inerziale del pilota.
Il tentativo di arrestare la rotazione agendo sul comando esterno al senso di rotazione può provocare lo stallo totale dell'ala.
Qualsiasi tentativo di trattenere la rotazione o evitare l'abbattimento, frenando in anticipo l'ala prima che abbia ripreso il volo, non farà altro che peggiorare la situazione e cioè l'ala assumerà altre configurazioni non prevedibili.
STALLO
Considerazioni generali . La mancanza di una struttura rigida rende lo stallo con il parapendio una condizione "temporanea", la cui evoluzione dipende dalla velocità con cui questo viene indotto e dalle caratteristiche dei singoli modelli.
L'evoluzione "stabile" è rappresentata dallo stallo paracadutale (vedi), mentre quella "instabile" è data dalla chiusura dell'intera vela, il cosiddetto post-stallo (vedi), sconosciuto con qualsiasi altro mezzo volante. Un caso particolare è dato dallo stallo dinamico, che può verificarsi come conseguenza dell'uscita da altri assetti inusuali.
Sullo stallo vero e proprio non ci soffermiamo oltre, avendolo già trattato nel capitolo di aerodinamica e parlando delle tecniche di pilotaggio; basti ricordare che ogni buon atterraggio viene in genere concluso con l'esecuzione di uno stallo completo.
STALLO PARACADUTALE
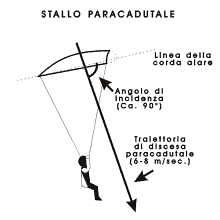
Figura 6-29. Durante lo stallo paracadutale l'angolo di incidenza (prossimo ai 90°) non permette lo sviluppo di portanza. È indispensabile far verificare attentamente la vela, individuandone il difetto.
|
Considerazioni generali . Lo stallo paracadutale è una condizione relativamente "stabile" che può verificarsi e mantenersi anche dopo che sono stati rilasciati i freni; nello stallo paracadutale l'avanzamento è nullo e la velocità verticale elevata.
Considerazioni aerodinamiche . Se il superamento dell'incidenza critica di stallo avviene molto gradualmente la vela, pur smettendo di sviluppare portanza, può rimanere comunque gonfia e non riprendere un assetto di volo neppure quando i freni vengono rilasciati, anche completamente. In questa configurazione il paracadute "torna alle origini", frenando la discesa per pura resistenza (come facevano, del resto, i "cupoloni" dello sbarco in Normandia) con velocità di discesa che possono r<1>aggiungere e superare gli 8 m/sec.
Induzione. Lo stallo paracadutale può essere indotto, nelle vele che lo "accettano", sia da uno stallo effettuato in modo estremamente graduale, sia eseguendo in modo errato l'uscita dallo stallo "B" (vedi).
Prevenzione . Poiché è piuttosto difficile indurre uno stallo paracadutale è molto semplice prevenirlo mantenendo sempre una ragionevole velocità di volo (evitando angoli di incidenza eccessivi). Deformazioni strutturali, come l'allungamento dei cavetti anteriori od una eccessiva regolazione dei trim posteriori, possono manifestarsi con una tendenza della vela a raggiungere e mantenere tale configurazione. In questi casi è necessario sottoporre ad una attenta verifica l'apparecchio (l'allungamento dei cavetti anteriori è stata una anomalia frequente con i primi parapendio, risolta dalla adozione di cavi "prestirati").
Manovra di recupero . Obbiettivo della manovra è quello di recuperare un angolo di incidenza compatibile con il volo: questo può essere ottenuto trazionando in basso le bretelle anteriori per qualche istante, rilasciandole e ponendo i freni in una posizione intermedia (in modo da contrastare l'avanzamento rapido che caratterizza il ripristino delle condizioni di volo). Più spesso, tuttavia, è preferibile affondare con decisione entrambi i freni per poi rilasciarli parzialmente: in questo modo viene eliminato il cuscinetto d'aria che, rimandendo intrappolato nell'intradosso, favorisce il mantenimento dello stallo dinamico stesso. Con alcune vele è necessario indurre un'uscita asimmetrica (trazionando un solo freno oppure una sola bretella anteriore) e recuperare rapidamente l'eventuale collasso asimmetrico che può conseguire. In ogni caso il manuale di istruzioni delle vele che possono andare in stallo paracadutale dovrebbe fornire (quantomeno) istruzioni specifiche per prevenire o risolvere il problema.
Errori o rischi . Il recupero da questa condizione richiede comunque parecchia quota e, quindi, la pericolosità dello stallo paracadutale è tanto maggiore quanto più vicini ci si trova al terreno.
POST-STALLO
Considerazioni generali . Il post-stallo è un collasso parziale della vela che viene indotto dalla trazione esagerata e mantenuta di entrambi i freni. È una condizione dalla quale la vela tende ad uscire molto (troppo) bruscamente qualora i freni vengano rilasciati senza alcun controllo da parte del pilota.
Considerazioni aerodinamiche . Da un punto di vista aerodinamico si tratta di uno stallo (portanza nulla, elevata velocità verticale, limitata soltanto dalla resistenza della vela) che permane finchè viene mantenuta la esagerata trazione sui freni. Se questi vengono rilasciati del tutto, la vela riprende a volare con grande velocità (improvviso ed elevato carico) schizzando in avanti ed in basso, potendo finire addirittura al di sotto del pilota con gli intuibili rischi connessi.
Prevenzione . È una manovra esclusivamente volontaria che, pertanto, non richiede alcuna misura di prevenzione.
Induzione . Accorciare temporaneamente i freni attorcigliandoli per uno o più giri intorno alle mani, abbassarli progressivamente sino a superare l'angolo di stallo e mantenerli in tale posizione sino a quando la vela, dopo un parziale sgonfiamento ed un apparente arretramento, torna a "stabilizzarsi" sulla testa del pilota con oscillazioni più o meno marcate.
Manovra di recupero . I freni debbono essere rilasciati in modo graduale, arrestandoli in una posizione intermedia, per limitare l'entità dell'accelerazione e della picchiata che conseguono il ripristino della portanza dell'ala. È molto importante effettuare questa manovra osservando il comportamento della vela, in modo da poter anticipare e correggere eventuali assetti asimmetrici che possono prodursi durante l'uscita dal post-stallo.
Errori o rischi . Il recupero deve essere effettuato dopo che la vela si è stabilizzata sulla verticale del pilota (sia pur con leggere oscillazioni) e, come detto prima, i freni non devono essere rilasciati completamente, bensì mantenuti in una posizione intermedia ad evitare un eccessivo abbastimento della vela.
STALLO DINAMICO
Considerazioni generali . Per la mancanza di una struttura rigida, lo stallo dinamico del parapendio può verificarsi solamente come risultato di successive oscillazioni di beccheggio via via più ampie (od in seguito ad una singola oscillazione "estrema" che può conseguire al recupero da un altro assetto inusuale).
Lo stallo, con relativa perdita di quota, si realizza mentre la vela è notevolmente arretrata ed il pilota in posizione avanzata.
Considerazioni aerodinamiche . Come ricordiamo, uno stallo dinamico si determina quando viene superato l'angolo critico di incidenza mentre la vela possiede ancora una discreta velocità. Con il parapendio (alta resistenza, bassa velocità rispetto alle ali rigide) questo assetto non può essere mantenuto e la vela tende ad eseguire una picchiata di recupero, anche molto pronunciata.
Induzione . Frenare gradualmente e rilasciare i comandi, determinando una oscillazione di beccheggio; amplificare successivamente tale oscillazione avendo cura di evitare, nella fase di picchiata, un collasso frontale.
Manovra di recupero . Rilasciare parzialmente i freni mantenendoli in una posizione intermedia in modo da limitare la successiva picchiata e smorzare, poi, l'oscillazione residua.
Errori o rischi . Rilasciare completamente i freni è un errore che può determinare una eccessiva picchiata di recupero, picchiata ulteriormente favorita dai ritardi di velocità del pilota rispetto alla vela.
ACROBAZIA
Vale forse la pena di ricordare che l'acrobazia si fonda sulla esecuzione successiva di manovre estreme, accuratamente pianificate in anticipo in modo da compensarsi od accentuarsi l'un l'altra dando luogo a figure comunque previste e prevedibili.
Essa non ha nulla a che vedere con la improvvisazione di un pilota colto da inarrestabile voglia di nuove emozioni, ma è invece il risultato di faticosi e ripetuti esercizi attentamente studiati, lo ripetiamo, "a tavolino", sotto la guida di istruttori esperti in questo campo. Anche per l'acrobazia valgono, ovviamente, le considerazioni di sicurezza ( specchio d'acqua, assistenza, quota minima, paracadute d'emergenza in perfette condizioni ) già esposte per i corsi di SIV.
|